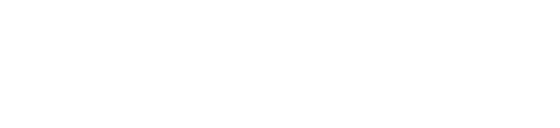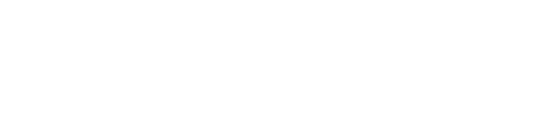Un romagnolo nel Berry
Cominciamo con una verità incontrovertibile: non si mangia bene solo in Romagna e ognuno ha il diritto di considerare che la cucina del suo paese è la migliore del mondo. Come dicono i napoletani, pure "‘o scarafone è bello a mamma sua". Ma questa regola conosce almeno un’eccezione: in nessun’altra parte del mondo si fa la sfoglia come in Romagna. Neppure in Emilia, neppure a Modena e neppure a Bologna. Dimostrazione: per rendere appetibile la loro pasta  all’uovo, i nostri amici e vicini emiliani sono costretti a migliorarla con ogni sorta di ripieno: e giù tortelli, tortellini, ravioli e agnolotti. O ad affogarla sotto chili di ragù, besciamella e parmigiano - ed ecco le lasagne.
all’uovo, i nostri amici e vicini emiliani sono costretti a migliorarla con ogni sorta di ripieno: e giù tortelli, tortellini, ravioli e agnolotti. O ad affogarla sotto chili di ragù, besciamella e parmigiano - ed ecco le lasagne.
Invece, la tagliatella romagnola - oh, la tagliatella romagnola! - "un rien l’habille", come direbbero i francesi: una noce di burro ed una spruzzata di parmigiano, un soffio di tartufo bianco se l’avete o, ancora, qualche pezzetto di prosciutto e due o tre piselli. Mmmmh, la tagliatella!
Tutto il suo segreto sta nella sfoglia. Io ve la spiego nell’unico modo possibile, cioè come la vedevo fare ogni mattina da mia madre, una delle più tremende arzdôre mai prodotte dalla fertile terra di Romagna, prima che noi bambini partissimo per andare a scuola e lei per andare a lavorare, mentre sul fornello borbottava il ragù.
Prima di tutto, l’operazione deve svolgersi sul campo di battaglia regolamentare: un grande tagliere da pasta sul quale la farina, la meno "raffinata" possibile, sarà impastata con le uova, le meno industriali possibile. Punto e basta. Niente acqua, che allora vuol dire che non siete capaci di fare la pasta come si deve e dovete recuperarla in extremis per renderla "tirabile". Niente sale, che potrebbe fare dei grumi: si salerà poi l’acqua di cottura.
E adesso vi ci vuole un paio di braccia d’arzdôra, per portare l’impasto a quel grado di compatta elasticità che gli permetterà di essere ridotto fine fine e senza appiccicarsi al tagliere.
Una volta portato l’impasto a questo suo stato ottimale, mettetelo sotto un canovaccio e lasciatelo riposare 15-20 minuti, al calduccio della cucina e soprattutto al riparo dalle correnti d’aria, che "guastano" la pasta.
Devo confessare che non ho mai capito se questa storia di preservare la pasta dalle correnti d’aria abbia qualche fondamento scientifico o sia pura superstizione, ma in fondo, per avere delle tagliatelle come Dio comanda, noi romagnoli saremmo capaci anche di inchiodare una civetta alla porta della cucina: nel Berry, dove abito adesso, lo fanno spesso, ma le loro tagliatelle sono schifose.
Bene, è il momento di sfoderare il mitico sgadùr (in italiano: il mattarello) che deve essere lungo e pesante. Niente a che vedere col ridicolo arnese da pasticciere che si vede qui in Francia né con la famigerata "macchinetta" per fare (per modo di dire) la pasta. Il metallo é una materia fredda, il cui contatto guasta irrimediabilmente la pasta, peggio delle correnti d’aria. La pasta che ne esce non ha alcuna rugosità alla quale la salsa possa aggrapparsi e la poveretta scivola via dalla vostra pseudo-tagliatella per ritrovarsi desolatamente sul fondo del piatto.
L’impasto va dunque appiattito un po’ alla volta col mattarello, uniformemente su tutta la sua superficie, fino a raggiungere quello spessore magico che non si misura in millimetri, ma schiacciando la sfoglia tra il pollice e l’indice.
Ma prima c’è la mossa con la quale la sfoglia, che comincia a prendere forma, viene girata da una parte e dall’altra. L’arzdôra l’arrotola completamente sul mattarello, al quale fa disegnare un mezzo cerchio nell’aria (un po’ il gesto con cui il torero fa roteare la muleta), poi con un colpo secco la manda a srotolarsi di nuovo sul tagliere. E’ questo l’atto iniziatico della vera arzdôra: solo quando saprete eseguire con naturalezza questa figura obbligatoria potrete dirvi veramente capaci di fare la sfoglia.
A questo punto vi risparmierò il numero del cerchio giallo come il sole, del disco d’oro che illumina la cucina e tutto il resto: a noi romagnoli le smancerie piacciono poco. La realtà é meno poetica e più spietata: la sfoglia, arrivata alla sua fase matura, ha una vita più effimera di quella di una libellula. Con un coltellaccio la si riduce letteralmente a fette: non troppo larghe, come quelle pappardelle toscane che vi strozzano quando cercate di deglutirle; non troppo sottili, che allora diventano dei tagliolini.
E adesso le parole mi mancano, ci vorrebbe un film di Fellini su uno script di Tonino Guerra, per cercare di farvi condividere quell’emozione mista ad orgoglio indicibile che vi fa venire il groppo in gola quando la mamma ficca le dita tra le striscioline di sfoglia appena tagliate, le solleva, le butta per aria e le fa spandere sul tagliere con un suono di frullo d’ali d’uccello: le tagliatelle sono nate lì, sotto i vostri occhi, ed é la mamma che le ha fatte!
Ma voi direte: cosa ci fa uno così nel Berry? Uno impegnato nell’opera di sacralizzazione della cucina emiliano (ma sì, siamo magnanimi…)-romagnola di fronte alla globalizzazione alimentare galoppante? Rispondo come faccio di solito, quando a porre la domanda sono i francesi: che sono venuto per completare l’opera di civilizzazione che il nostro buon Caio Giulio Cesare ha lasciato incompiuta più di venti secoli fa, a causa d’urgentissimi impegni al di là del Rubicone.
Per essere più chiaro, una ventina d’anni fa, mi sono dovuto arrendere ad una inquietante evidenza: arrivati alle soglie della quarantina, o si fa una svolta radicale o si muore. Sono dunque partito, il giorno della Befana 1992, alla volta della Ville Lumière, che mi ha però ben presto presentato la bolletta (delle sue lumières) : troppo cara per i miei mezzi. Conoscevo già da qualche anno la città di Bourges, gemellata con la mia Forlì natale: ho scelto la sua tranquillità, che ben si confà al mio bisogno di "darmi una calmata", e infine - cherchez la femme - una signorina che vi risiedeva e che è divenuta la mia compagna e la madre di nostra figlia Chiara.
Installatomi dunque comodamente nell’antica capitale dei Biturigi, sono riuscito, grazie alla duttilità mentale che caratterizza da sempre noi italiani - e che si potrebbe anche chiamare arte d’arrangiarsi - a fare una spettacolare riconversione dal grigio impiego di responsabile del centro elettronico dell’INPS di Forlì alla pregevole professione di consulente in conservazione preventiva dei beni culturali. Cos’è - direte - la conservazione preventiva? E’ per i beni culturali più o meno quello che la medicina preventiva è per la sanità. Siamo dunque dei consulenti privati che lavorano principalmente per i musei che hanno dei problemi o dei progetti di ristrutturazione. Insomma, come si dice nella lingua di Yves Montand, "je me la coule douce": e questo mi permette di occuparmi di varie attività collaterali, come la locale Associazione Francia-Italia, la pratica militante del tango argentino e la collaborazione alla rivista Focus Magazine.