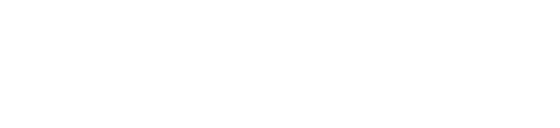Da Theresienstadt a Treblinka
Dopo un mese a Theresienstadt, mi fu comunicato che il giorno dopo dovevo partire per un altro campo verso est. Corsi a salutare Hanna, mia cugina – la quale mi disse che il nonno era appena morto, proprio quel giorno.
Noi, il nostro trasporto di céchi, viaggiammo in un treno passeggeri; in seguito avrei scoperto che questa era una cosa assai rara; soltanto trasporti dall’Occidente – dalla Germania, dall’Austria, dall’Olanda, eccetera – viaggiavano su treni passeggeri con relativa comodità: tutti gli altri su carri-bestiame. Il servizio di sorveglianza sul nostro trasporto era svolto da poliziotti – con la divisa verde della polizia. Alcuni giovani vennero nominati capigruppo, e gli furono dati dei bracciali. Non fu un viaggio particolarmente duro né pauroso. E’ vero che l’ufficiale di polizia che comandava il trasporto si espresse in una maniera piuttosto strana. <<Mi è stato ordinato di portare mille pezzi,>> disse <<e porterò mille pezzi. Perciò, se qualcuno mette fuori la testa dal finestrino, gli salta via: noi spariamo>>.
Pensammo che un linguaggio così crudo era del tutto fuori luogo; non c’era nessun bisogno, pensammo, di spaventare a quel modo le donne e i bambini; ma non ci soffermammo a riflettere su questo neanche per un secondo. Partimmo da Theresienstadt l’8 ottobre, e viaggiammo due giorni. Prima pensammo che stavamo andando in direzione di Dresda, ma poi il treno deviò verso oriente. Durante la notte, era più il tempo che stava fermo che quello che si muoveva. L’ultima mattina vedemmo in distanza la sagoma di una città; doveva essere Varsavia. Arrivammo a Treblinka alle tre e mezzo del pomeriggio. Tutti ci affollammo ai finestrini. Vidi una siepe verde, ddelle baracche, e udii un rumore che sembrava quello di un trattore agricolo. Ero felice. Quel posto sembrava una fattoria. Pensai: <<E’ una cosa meravigliosa; farò un lavoro che già conosco abbastanza>>. […]
Sulla piattaforma, vidi degli uomini con dei bracciali azzurri, ma senza nessun grado. Uno di loro portava uno scudiscio – di un tipo che non avevo mai visto, sembrava uno scudiscio per grossi animali. Parlavano un tedesco molto strano. C’erano annunci ad alta voce, ma tutto quanto era abbastanza moderato: nessuno ci fece nulla [era la linea di condotta prescritta per i convogli che arrivavano dall’Ovest]. Io seguii la folla: <<Gli uomini a destra, le donne e i bambini a sinistra>> ci dissero. Le donne e i bambini scomparvero dentro una baracca un po’ discosta, a sinistra, e a noi dissero di svestirci.
Una delle SS – più tardi seppi il suo nome, Küttner – ci disse in tono conversevole che andavamo a un bagno di disinfezione, dopo di che ci sarebbe stato assegnato il nostro lavoro. Disse che gli abiti dovevano essere lasciati in un mucchio sul pavimento, e che li avremmo ritrovati più tardi. Dovevamo portar con noi i documenti, la carta d’identità, il denaro, gli orologi, e i gioielli.
La coda cominciò ad avanzare, e d’un tratto notai diversi uomini interamente vestiti, in piedi presso un’altra baracca, un po’ più lontano, e mi domandai chi potessero essere. Proprio in quel momento un’altra SS (si chiamava Miete), mi venne vicino e disse: <<Vieni fuori, tu, rimettiti i vestiti, presto, lavoro speciale>>. Fu questo il primo momento in cui ebbi paura. Tutto era molto silenzioso. E quando lui mi disse questo, gli altri si voltarono e mi guardarono – e pensai, mio Dio, perché proprio io, perché è venuto a pescare proprio me? Quando mi fui rivestito, la coda era avanzata, e notai che diversi altri giovani erano stati tirati fuori dalla fila e si stavano rivestendo. Fummo portati nella baracca di lavoro, che era in gran parte piena di indumenti dal pavimento al soffitto, strato su strato. Molti di questi indumenti erano sporchi – dovevamo separarli a forza, tanto erano incollati dal sudiciume e dal sudore. Il sorvegliante mi mostrò come dovevo legare insieme i mucchi in fagotti, avvolgendoli con lenzuola o con teloni.
Capisce, non ci fu tempo, neanche un attimo, tra il momento in cui fummo fatti entrare là dentro e quello in cui fummo messi al lavoro, per parlare con qualcuno, per farci un’idea di quello che stava succedendo… e, naturalmente, non dimentichi che non avevamo alcun’idea dello scopo di tutta quella installazione.
(G. Sereny, In quelle tenebre, Milano, Adelphi, 1999, pp. 236-238. Traduzione di A. Bianchi)