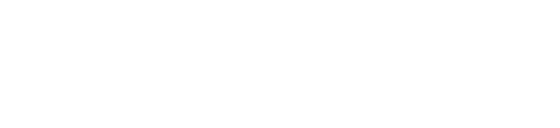I primi rastrellamenti nel ghetto di Varsavia
Oggi, 31 agosto, comincio a scrivere queste righe bagnate di sangue e di lacrime. Sono passati ormai quaranta giorni dal momento in cui i cani sanguinari hitleriani, insieme agli infami aguzzini della cosiddetta polizia ebraica, hanno cominciato a sterminare con feroce crudeltà la popolazione ebraica del ghetto di Varsavia.
Circondato da tutte le parti da mura desolate, fatte costruire dal Judenrat [= Consiglio ebraico – n.d.r.] a proprie spese, il ghetto di Varsavia contava al 22 luglio 1942 circa trecentocinquantamila anime. La gente si ammucchiava nelle strade strette, sporche, buie.
Il tifo che ha fatto strage per tutto l’inverno, falciava le vittime, la fame mieteva da quattro a cinquemila vittime al mese. I cani hitleriani sparavano e uccidevano gente ogni giorno, tuttavia gli ebrei vivevano, in un modo o nell’altro (una piccola percentuale stava benissimo) e non perdevano la speranza di riuscire ad avere infine ragione del cane feroce, dell’assassino.
Venne però una giornata nera, la più nera forse di tutta la storia ebraica, la giornata del 22 luglio 1942. […] Apparvero sui muri dei manifesti con un comunicato del Judenrat che annunciava l’ordine delle autorità tedesche: tutti gli ebrei devono essere trasferiti da Varsavia (in termine tedesco: uebergesiedelt) nelle regioni dell’Est. A Varsavia potranno rimanere: i poliziotti ebrei (con mogli e figli), gli impiegati del Judenrat, gli impiegati dell’Ufficio Approvvigionamento, gli impiegati del Comitato Ebraico di Soccorso ed anche gli ebrei idonei al lavoro. Tutti costoro saranno alloggiati in apposite caserme, dove saranno addestrati ad una vita disciplinata e lavoreranno per l’esercito tedesco.
Il trasferimento – diceva ancora il comunicato – comincia oggi stesso, alle ore 11. Chi si nasconderà, o farà resistenza, sarà fucilato immediatamente.
La trista operazione cominciò ad attuarsi. I poliziotti ebrei, quei duemila cani dei quali avrò più tardi occasione di parlare, si misero subito al lavoro.
Le prime vittime furono gli ebrei a suo tempo deportati dalla Germania, che già erano stati trasferiti decine di volte da una località all’altra; alla fine li avevano gettati nel ghetto di Varsavia, stranieri senza tetto, impacciati. Bisogna dire, sia pure a malincuore, che non erano persone troppo simpatiche. Erano tedeschi, rinnegavano gli Ostjuden [= gli ebrei dell’Europa orientale, più legati alla tradizione e più distanti dalla moderna cultura europea – n.d.r.], li insultavano, e quando lavoravano nelle aziende tedesche e avevano un po’ di voce in capitolo, maltrattavano gli ebrei locali.
Il cane feroce, Hitler, possiede una forza così diabolica che riesce ad aizzare il fratello contro il fratello, il figlio contro il padre, perché lottino a somiglianza dei lupi e siano portati a dilaniarsi a vicenda. Gli ebrei tedeschi accolsero con calma il loro destino. I poliziotti ebrei li condussero all’Umschlagplatz [= posto di smistamento, il luogo in cui gli ebrei erano caricati sui vagoni – n.d.r.], o più propriamente alla piazza delle sofferenze e della morte che divenne poi il simbolo della Geenna: nel pronunciare questa parola si sente il sangue gelarsi nelle vene e il cuore fermarsi.
Una volta sistemati gli ebrei tedeschi, i poliziotti si accinsero al lavoro nei cosiddetti punti, dove si trovavano ammassate decine di migliaia di disgraziati, deportati tempo addietro dalle loro città d’origine per farli morire di fame e di tifo sotto la protezione del Judenrat. Nel ghetto di Varsavia un punto significava una topaia desolata, sporca, trascurata, dove la gente ancora sana dormiva sullo stesso giaciglio dei malati di tifo, dove i vivi giacevano insieme ai morti e dove si invocava cento volte al giorno la morte. Il Judenrat di Varsavia che pompava denaro dai vivi e dai morti, l’Ufficio Approvvigionamento, i cui direttori ammassavano oro, si curavano tanto dei punti, che quelli che vi abitavano cadevano come le mosche.
Quando si entrava in un punto non si vedevano esseri viventi, ma cadaveri ambulanti, fantasmi , ossa e pelle che marcivano. Questi spettri, per la verità, non si interessavano molto del loro destino; erano comunque condannati, che cosa importava il luogo dove avrebbero trovato la morte? I cani hitleriani fucilarono questi disgraziati uno ad uno.
Tuttavia anche fra loro c’era qualcuno che non voleva lasciarsi prendere; si difendevano, gridavano, si nascondevano. Allora i poliziotti del ghetto, per la maggior parte ebrei convertiti, avvocatucci senza fortuna, figli di ricchi commercianti, gioventù dorata dell’anteguerra, dimostravano di che cosa erano capaci.
Si mettevano a picchiare ferocemente quei disgraziati con manganelli e bastoni d’ogni genere. Strappavano i bimbi alle madri, i mariti alle mogli, i padri ai figli. Le grida di disperazione si alzavano fino al cielo, ma i nostri poliziotti, sia maledetto il loro nome, avevano cuori di pietra. Non smettevano di picchiare. Caricavano la gente sui carri e la portavano alla famosa Umschlagplatz. Su carri simili i condannati a morte vengono portati al patibolo.
In quella notte fra il 22 e il 23 di luglio 1942, il presidente del Judenrat, ingegner Czerniakov, si uccise dopo una visita dei cani hitleriani, che gli avevano chiesto di consegnare all’indomani diecimila ebrei. […] Era un uomo mediocre e povero di spirito e il destino beffardo lo aveva messo a capo della più grande comunità ebraica di tutta l’Europa, in un periodo che non aveva precedenti nella storia degli ebrei. Questo ingegnere non era all’altezza di un compito così grande, e nello stesso tempo così tragico, che superava i limiti delle sue forze, e non si rendeva conto della responsabilità che si era assunto. Dirigeva la comunità come un piccolo amministratore dalle vedute ristrettissime e, diciamolo pure, come un grande codardo. Faceva tutto quello che i banditi hitleriani gli chiedevano; non osava mai alzare la voce, non osava mai muovere un’obiezione, sia pur minima. Pensava forse, che così facendo, sarebbe riuscito a salvare il salvabile. E invece non salvò niente, né se stesso, né gli altri membri del Judenrat, che strisciavano carponi davanti ai banditi tedeschi.
(A.Nirenstajn, Ricorda cosa ti ha fatto Amalek, Torino, Einaudi, 1958, pp. 58-66)