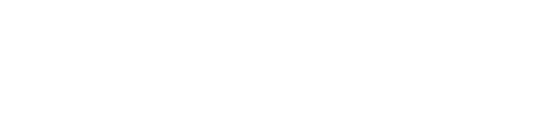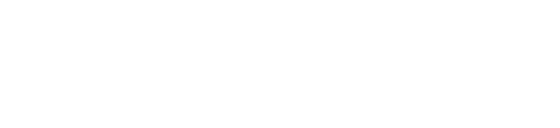L'impiego dei gas in Etiopia
Le grandi potenze e gli aggressivi chimici
 I gas (o meglio, aggressivi chimici) furono impiegati per la prima volta e su grande scala durante la prima guerra mondiale. Il numero dei soldati uccisi da questi agenti non fu elevatissimo, rapportato al totale dei caduti; il gas provocò infatti la morte di circa 30 000 inglesi, francesi e tedeschi presi assieme, cui vanno aggiunti 56 000 russi. A monte dell’evidente discrepanza tra i caduti russi e quelli delle altre potenze, sta l’equipaggiamento dell’esercito zarista, particolarmente scadente e inidoneo a difendere il soldato dalla nuova minaccia.
I gas (o meglio, aggressivi chimici) furono impiegati per la prima volta e su grande scala durante la prima guerra mondiale. Il numero dei soldati uccisi da questi agenti non fu elevatissimo, rapportato al totale dei caduti; il gas provocò infatti la morte di circa 30 000 inglesi, francesi e tedeschi presi assieme, cui vanno aggiunti 56 000 russi. A monte dell’evidente discrepanza tra i caduti russi e quelli delle altre potenze, sta l’equipaggiamento dell’esercito zarista, particolarmente scadente e inidoneo a difendere il soldato dalla nuova minaccia.Nel 1928, tutti i principali Paesi del mondo (con la sola eccezione significativa degli Stati Uniti) firmarono una convenzione per la messa al bando degli aggressivi chimici. Nessuno Stato, però, rinunciò a fabbricarli, Italia compresa. Anzi, l’esercito del nostro Paese fece ampio uso di gas in Libia, tra il 1923 e il 1931, contro i ribelli che si opponevano alla dominazione coloniale italiana.
L’aggressivo chimico più micidiale, negli anni Trenta, era l’iprite (chiamato mustard gaz dagli inglesi). In Italia, la produzione giornaliera di iprite negli anni 1935-1936 passò da 3 a 18 tonnellate al giorno. Nel complesso, durante la guerra, ne sarebbero state rovesciate sugli etiopici circa 300 tonnellate sul fronte settentrionale (cui vanno aggiunti i 30 500 kg utilizzati sul fronte somalo).
Le responsabilità di Mussolini, Badoglio e Graziani
Dalla frammentaria documentazione sopravvissuta, risulta che sia stato Graziani (il 12 ottobre 1935) il primo a chiedere l’autorizzazione ad usare tutti i mezzi (compresi gli aggressivi chimici) contro il nemico. Tale autorizzazione gli fu concessa da Mussolini il 27 ottobre. A fine anno, quando Badoglio rilevò De Bono al comando del fronte nord (17 novembre), il nuovo generale si trovò in difficoltà ad arrestare la violenta controffensiva etiopica. Pertanto, prim’ancora di ottenere un formale permesso dal Duce (28 dicembre), Badoglio ordinò l’uso dei gas (20 dicembre). Gli attacchi chimici proseguirono per circa tre mesi (l’ultimo documentato risale al 31 marzo 1936).
L’iprite era gettata sul nemico dall’aviazione. Ad essere colpite erano soprattutto le retrovie, nei loro punti più strategici (strade, villaggi, guadi, accampamenti, corsi d’acqua...). Le bombe più utilizzate erano denominate C.500.T : ciascuna di esse pesava 280 kg e conteneva circa 216 kg di iprite. Ogni bomba irrorava di goccioline di liquido corrosivo (e, quindi, mortale) un’area ellittica di circa 500/800 metri per 100/200 metri. Gli effetti duravano diversi giorni: per questo motivo, l’iprite era usata solo lontano dal fronte, in modo che non potesse colpire soldati italiani. Per la stessa ragione, nessun reparto italiano (con l’ovvia esclusione degli aviatori) ha mai assistito ad un attacco condotto contro il nemico mediate gli aggressivi chimici.