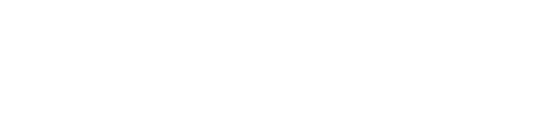Sfinimento e disperazione negli anni della guerra
Le tormente potevano durare non ore, ma giorni. I corpi dei prigionieri dispersi non venivano ritrovati fino alla primavera successiva, magari a soli cento metri dal comprensorio. Poiché queste bufere sconvolgevano l’aspetto consueto del campo di lavoro forzato, nascondendo i simboli della libertà perduta – le torrette di guardia, le spire di filo spinato – cancellavano anche il senso opprimente di esserci rinchiusi. Talvolta fantasticavo che le tormente ci liberassero, che la loro forza spazzasse via il comprensorio, il campo di lavoro, l’intera area della Kolyma e che, una volta cessata la furia, tornassimo a essere liberi. La natura rappresentava per me una continua sorpresa, mi lasciava sempre stupito, mi rammentava in ogni occasione quanto fossimo vulnerabili noi tutti che eravamo lì, prigionieri e guardie, nel duro inverno artico che non risparmiava nessuno.
Con il freddo si presentarono nuovi pericoli. Eravamo dispensati dal lavoro solo quando la temperatura scendeva oltre i quarantacinque gradi centigradi sotto lo zero, mentre il vento, per quanto gelato, non veniva preso in considerazione. Già quando la temperatura scendeva fra i trenta e i trentacinque gradi sotto lo zero la respirazione diventava difficoltosa. Poi, fra i trentotto e i quarantacinque gradi pungeva molto dolorosamente. Era pericoloso smettere di muoversi. Durante l’appello, saltellavamo, correvamo sul posto, ci davamo manate su tutto il corpo. In continuazione mi sfregavo le mani, le chiudevo a pugno, le riaprivo e le richiudevo. Stavo molto attento alla sensibilità delle dita dei piedi, delle orecchie, del naso e di tutte le zone più esposte al congelamento. Jurij e io ci controllavamo reciprocamente, gridandoci: "Sfregati le orecchie!", "Guarda che hai le guance blu!", "Strofinati il naso!". Cercavo di tenere il mento affondato nel petto e alzavo il bavero del giaccone, coprendo il resto della faccia con la camicia. [...]
Al freddo, ogni fase del lavoro in miniera si faceva più difficoltosa, però le quote di scavo previste, le ore lavorative e le razioni di cibo restavano le stesse. I più fortunati riuscirono a mantenere la razione di prima categoria, ma quelli che scivolarono nella seconda o nella terza cominciarono presto a non farcela più e a deperire progressivamente. Una differenza di soli trecento grammi di pane e una scodella in più o in meno di zuppa d’avena potevano significare la vita o la morte; la differenza tra l’alzarsi il mattino e il rimanere sul tavolaccio significava finire in isolamento che era un deterrente contro qualsiasi cedimento alla pigrizia. Nessuno restava nella tenda per un riposo supplementare o per riguadagnare le forze, perché di solito, chi lo faceva, poi non si vedeva più.
Un giorno notai Fëdor Babinic che camminava con passo malcerto tra le baracche. [...] Si fermava a guardare fisso negli occhi l’uno o l’altro, come un cane che domandasse silenziosamente qualcosa da mangiare. Per tutta risposta, gli sputavano addosso, lo insultavano, lo spingevano da parte. Caduto, lo aiutai ad alzarsi e lo accompagnai al suo posto. Mi riconobbe, ma gli occhi erano come vuoti. Sapeva ormai dire solo che era affamato e ripetutamente domandò del cibo. Il suono della voce sembrava salirgli dal fondo dello stomaco, insieme a un orribile odore bilioso.
Ce n’erano molti ridotti in quel modo, li avevo visti gradualmente trasformarsi da lavoratori determinati a mangiarifiuti derelitti e scavati, tristi figure che leccavano le scodelle vuote, rovistavano fra le immondizie, imploravano con gli occhi. Mi resi conto che, a determinare il destino di un individuo, non erano solo l’età, la forza, la salute, l’educazione, la fede religiosa, il modo in cui era cresciuto. Ciò che divideva chi crollava da chi resisteva erano due cose difficili da controllare perché del tutto indipendenti dalla volontà di sopravvivenza. Una discendeva, sì, dalla persona, ed era la resistenza fisica e mentale, ma l’altra veniva da chissà quale parte dell’universo, ed era la fortuna o il fato.
D’inverno, il letto a cui si fermava la morte era prossimo a quello di chiunque altro. La morte sopraggiungeva nei siti di lavoro, ma, per qualche ragione, si moriva di più nelle baracche, di notte. Al mattino, appena si scopriva che qualcuno era morto, il cadavere veniva spogliato dagli altri prigionieri. [...] Gli inservienti nelle baracche, solitamente invalidi o anziani criminali, facevano rapporto sui decessi e ammassavano i cadaveri nudi in qualche posto nel bosco, dove restavano finché non fosse cominciato il disgelo e si potesse scavare una fossa. Era stata creata una piattaforma di legno, affinché i corpi non fossero sepolti dalla neve o raggiunti dagli animali, ma notammo diverse orme che convergevano sul luogo. Le guardie e i pridurki [= prigionieri investiti dell’incarico di sorveglianti degli altri detenuti - n.d.r.] avevano un certo piacere ad avvisarci che i lupi erano particolarmente pericolosi d’inverno, come confermavano i cadaveri parzialmente mangiati. Riferendosi a quella minaccia, parevano piuttosto compiaciuti.
Non solo gli animali erano alla ricerca disperata di cibo. I mangiatori di cibo avariato stazionavano intorno alla stufa della tenda: bollivano e mangiavano rimasugli di carne putrida e strana. Sentii da qualcuno che la prendevano dalla pila di cadaveri nel bosco, ma mi riusciva difficile crederlo, oltre a sentirmi profondamente turbato da una simile eventualità. Non avevo ancora capito quello che la fame può spingere a fare, ed ebbi un certo travaglio interiore a non giudicare in modo sbrigativo questa gente.
Riflettevo spesso sul mio comportamento: se fossi stato altrettanto affamato e disperato, avrei fatto lo stesso? Dapprima pensai che sarei morto piuttosto che mangiare carne umana, ma, quando cominciai a declinare, non potei più essere così sicuro.
(J. Bardach – K. Gleesen, L’uomo del gulag, Milano, Il Saggiatore, 2001, p. 257-260. Traduzione di G. Bernardi)