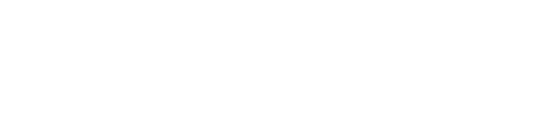I musulmani di Buchenwald
"Sono già qui!" esclama d’improvviso.
La sua voce è insolitamente acuta, e pare irritata. Volto la testa, seguo la direzione del suo sguardo. In effetti sono già qui. Stanno arrivando. Avanzano a passi corti, a volte appoggiandosi gli uni agli altri, o usando bastoni o stampelle improvvisate; strappando gli zoccoli dalla neve fangosa; con uno scalpiccio irregolare, lento ma ostinato, sono già qui.
Senz’altro vorranno sfruttare quella domenica con il sole d’inverno. Ma sarebbero comunque arrivati una qualsiasi altra domenica, anche in mezzo a tempeste di neve e di pioggia. Arrivavano sempre di domenica, dopo l’appello, non gliene importava del tempo che c’era.
Le latrine collettive del Campo Piccolo erano il loro luogo di ritrovo, di scambio, di conversazione, di libertà. Mercato dei ricordi, e anche di scambi, in mezzo all’odore appestante degli escrementi. Per nulla al mondo, per grande che fosse lo sforzo che significava – almeno nella misura in cui uno sforzo fosse ancora possibile - , avrebbero rinunciato ad arrivare in quelle domeniche pomeriggio.
"Quei merdosi musulmani..." bofonchiò Kaminsky.
Fu lui a utilizzare per la prima volta quella parola, musulmani, davanti a me. Io conoscevo già la realtà che quel nome designava: lo strato infimo della plebe del campo di concentramento, che vegetava al margine del sistema dei lavori forzati, tra la vita e la morte. Ma io non sapevo ancora, fino al giorno in cui Kaminsky la utilizzò, che questa parola – la cui origine è oscura e controversa – esisteva come termine generico nel gergo di tutti i campi nazisti.
Prima di conoscere la parola musulmani, io davo, ai deportati che mostravano indizi caratteristici di decadenza fisica e di atarassia morale [= apatia psichica – n.d.r.], nomi che provenivano dalla vita precedente: Lumpen o vagabondi. Sapevo molto bene che era un’espressione approssimativa, che la società di un campo di concentramento non poteva paragonarsi in nessun caso a quella di fuori, ma quelle parole bastavano per farmi comprendere ciò che vedevo.
Il giorno in cui utilizzò il termine per la prima volta, compresi che a Kaminsky non piacevano i musulmani. Ma questo non è il modo giusto per dirlo. Non è il fatto che gli piacessero o non gli piacessero. É che i musulmani lo irritavano. Solo perché esistevano, rovinavano la visione che si era fatto dell’universo del campo. Contraddicevano, addirittura negavano il comportamento che gli pareva indispensabile per sopravvivere. I musulmani avevano introdotto nel loro orizzonte ideologico un elemento di incertezza inaccessibile, poiché sfuggivano – per la loro stessa natura, la loro marginalità improduttiva, la loro atarassia - alla logica manichea della resistenza, della lotta per la vita: la sopravvivenza.
I musulmani stanno oltre tali nozioni: oltre la vita, la sopravvivenza. Tutti i nostri sforzi per mantenerci uniti, per appoggiarci gli uni agli altri, devono apparire loro incongruenti. Addirittura irrisori. Perché? Loro stanno già in un altro mondo, fluttuando in una specie di nirvana cachettico, in un nulla di bambagia in cui è stato abolito ogni valore, in cui solo l’inerzia vitale dell’istinto – luce tremante in una stella morta: anima e corpo svuotati – li mantiene in movimento.
"Quei merdosi musulmani" borbottò Kaminsky.
(J. Semprún, Vivrò col suo nome, morirà con il mio. Buchenwald 1944, Torino, Einaudi, 2005, pp. 26-28. Traduzione di P. Collo e P. Tomasinelli)