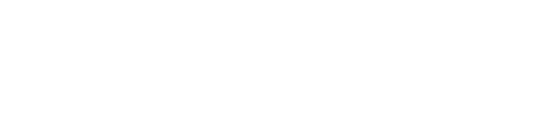Riflessioni sul lager
Camon. – Lei si fece dunque un anno di lager. Il lager, la metafora per eccellenza dell’uomo che fa male all’uomo, una delle massime colpe della storia. Da qualche parte Benjamin ha detto però che il lager non è una condizione abnorme e priva di confronti col resto del mondo: il lager non è che un grado condensato di una condizione che è generale nel mondo. Il lager è anch’esso, insomma, speculare alla struttura di ogni società: anch’esso ha i salvati e i sommersi, gli oppressori e gli oppressi.
Levi. – Le rispondo in due tempi. In primo tempo con una repulsione: questo paragone del mondo col lager, in noi – noi tatuati, noi segnati – suscita una rivolta: no, non è così, non è vero che la Fiat sia un lager: alla Fiat la camera a gas non c’è, e nell’ospedale psichiatrico si sta molto male ma non c’è il forno, c’è una via d’uscita, si ricevono i parenti. Queste scritte sui muri, viste qualche volta, fabbrica uguale lager, scuola uguale lager, mi rivoltano: non è vero. Tuttavia, e questo è il secondo tempo, possono valere come metafora. L’ho scritto io stesso in Se questo è un uomo, che il lager era uno specchio della situazione esterna, però uno specchio deformante. Per esempio, l’instaurarsi automatico e fatale di una gerarchia all’interno delle vittime è un fatto su cui non si è ragionato abbastanza; il fatto che esista dappertutto il prigioniero che fa carriera sulle spalle dei suoi compagni.
Camon. – E’ una condizione non necessaria o necessaria al funzionamento del lager?
Levi. – E’ utile al funzionamento del lager. Veniva sfruttata dai nazisti; ma anche se non fosse stata favorita, esisteva comunque. Soprattutto dove viene a mancare la legge si instaura la legge della giungla, la legge darwiniana, per cui il più adatto, che per lo più è il più cattivo, prevale e sopravvive, mangiando la carne viva dell’altro. Questo fenomeno nel lager era vistoso.
Qui devo fare una parentesi. Io ho vissuto il lager nelle condizioni peggiori, cioè come ebreo. In molti diari di politici si raccontano storie molto diverse, ma non c’è contraddizione. Le condizioni in cui i politici vivevano il lager erano diverse dalle nostre, perché avevano un’armatura morale e anche politica che ai più di noi mancava. Alcuni ebrei erano, sì, anche dei politici; io stesso in una certa misura lo ero, perché ero stato partigiano: un certo senso del ritegno e del dovere di resistere a questo risucchio dal basso lo possedevo. Ma i miei compagni di lager non erano dei politici, erano la schiuma della terra, erano degli infelici che avevano alle spalle cinque anni di persecuzioni continue, erano gente che dalla Germania nazista era scappata magari in Polonia o in Cecoslovacchia, per essere raggiunta anche lì e approdare finalmente ad Auschwitz; oppure poveri diavoli dell’Ucraina, della Bielorussia, della Polonia orientale, senza contatti con la civiltà occidentale, scaraventati di colpo in una condizione che non capivano. Era questo materiale umano quello che avevo intorno a me. In mezzo a questi infelici non c’era solidarietà, non c’era; e questa mancanza era il primo trauma, il trauma più grosso. Ingenuamente io e quelli che avevano viaggiato con me avevamo pensato: “Per mal che vada troveremo dei compagni”. Questo non risultò vero. Si trovavano dei nemici, non dei compagni. […]
Camon. – E la coscienza di patire tutti una comune ingiustizia non vi univa?
Levi. – Non abbastanza. Per molti motivi. Il motivo fondamentale è che mancava la comunicazione: e questo era il secondo trauma. Pochi fra noi ebrei italiani capivano il tedesco o il polacco; pochissimi. Io sapevo qualche parola di tedesco. L’isolamento linguistico, in quelle condizioni, era mortale. Sono morti quasi tutti gli italiani per questo. Perché fin dai primi giorni non capivano gli ordini, e questo non era ammesso, non era tollerato. Non capivano gli ordini e non potevano dirlo, non potevano farsi capire. Sentivano un urlo, perché i tedeschi, i tedeschi militari, urlano sempre…
Camon. – Per “dar vento a una rabbia vecchia di secoli”.
Levi. – Ho scritto così in Se questo è un uomo. E questo era il terzo trauma. Per loro è naturale, avviene nel loro esercito anche adesso: gli ordini si urlano. Bene: l’ordine veniva urlato ma non si capiva, quindi si arrivava sempre ultimi. Chiedevi informazioni, notizie, spiegazioni al tuo compagno di letto e quello non ascoltava e non capiva.
Questo fatto era già un primo grosso ostacolo all’unione, al riconoscersi come compagni. Io – l’ho sempre detto che sono stato fortunato – mi son trovato a possedere un minimo di lingua tedesca, l’avevo studiata come chimico, e ho potuto poi instaurare una certa comunicazione con i non italiani: e questo era fondamentale per capire dove vivevo, il decalogo di quel luogo. E anche per percepire questo senso di unione di cui lei parla. Infatti ricordo che quando si stabilirono dei contatti con amici prigionieri francesi, ungheresi, greci, ci sembrava di essere saliti di un gradino.
F. Camon, Conversazione con Primo Levi, Milano, Garzanti, 1991, pp. 27-31