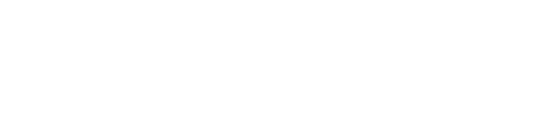Il dialogo con Giorgio Perlasca
“Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto?”.
Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell’interlocutore. Un quesito breve che supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di chi ascolta. “Avevo paura, sono scappato… Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?”. “Nessuno mi vedeva, l’ho fatto… Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?”.
Ma il vecchio signore che me la poneva, non cercava comprensioni o scusanti. Al contrario, stava cercando di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era comportato lui.
Era l’autunno del 1989. A fine settembre, su diversi quotidiani italiani, nello spazio accordato alle notizie brevi, era stato segnalato che a Gerusalemme era stato insignito di prestigiose onorificenze statali un cittadino italiano, il signor Giorgio Perlasca, di ottant’anni, che nel 1944 a Budapest era riuscito a salvare migliaia di ebrei ungheresi destinati alla deportazione nei campi di concentramento. Poche righe aggiungevano che la sua vicenda era rimasta sconosciuta per quasi mezzo secolo ed era venuta alla luce in seguito alla tenace ricerca condotta da alcuni sopravvissuti; altrettante poche e vaghe righe venivano spese per accennare al contesto dei fatti: il signor Perlasca si era fatto passare per un diplomatico spagnolo e in questa veste era riuscito a portare avanti la sua opera di salvataggio. […]
Dunque, signor Perlasca: perché lo fece?
“Perché non potevo sopportare la vista di persone marchiate come degli animali. Perché non potevo sopportare di veder uccidere dei bambini. Credo che sia stato questo, non credo di essere stato un eroe. Alla fin dei conti, io ho avuto un’occasione e l’ho usata. Da noi c’è un proverbio, che dice: l’occasione fa l’uomo ladro. Ebbene, di me ha fatto un’altra cosa. Improvvisamente mi sono ritrovato ad essere un diplomatico, con tante persone che dipendevano da me. Che cosa avrei dovuto fare, secondo lei? Piuttosto, penso che essere un falso diplomatico mi abbia aiutato, perché ho potuto fare delle cose che un diplomatico vero non farebbe. Eh… I diplomatici sono persone strane. Non è che siano proprio liberi di fare quello che vogliono. C’è l’etichetta, ci sono le formalità, le gerarchie, qualcuno a cui rispondere, la propria carriera. Tante cose, tanti vincoli che io non avevo”.
A guardare le poche fotografie che gli rimangono di quel periodo, il ruolo del diplomatico Perlasca certamente lo poteva sostenere. Trentaquattro anni, molto alto, portamento elegante. Decisamente un bell’uomo con i capelli chiari e gli occhi azzurri. Parlava correntemente lo spagnolo, si faceva intendere a sufficienza in tedesco e ungherese. […]
“E’ strano che tutto questo mi succeda proprio adesso… E’ strano perché io, quando tornai, la storia provai a raccontarla, ma sembrava che nessuno mi credesse. Probabilmente non interessava, o forse sembrava troppo enorme. Pensi che nemmeno mia moglie mi credeva. Sa quale fu l’unico legame in quegli anni con gli avvenimenti di Budapest? Un mio conoscente italiano cui avevo chiesto l’automobile in prestito negli ultimi giorni dell’assedio. Venne mitragliata e andò perduta e lui venne fino a Trieste per farsi rimborsare… D’altra parte, era nei patti. A quel tempo, dopo la guerra, io vivevo a Trieste e divenni membro del direttivo dell’Uomo Qualunque, e anche partecipante della Giunta d’Intesa per Trieste dei partiti politici italiani. Andai anche a Roma, come membro di una delegazione che chiedeva che fosse assegnata ai cantieri di Trieste la ristrutturazione della motonave Biancamano. Ho raccontato a diverse persone quello che avevo fatto. Ne ho parlato a De Gasperi, a Pella, al presidente dei liberali triestini Forti. Avevo scritto un diario e lo consegnai al Messaggero Veneto. Non ne fecero nulla, tanto che nel 1952 andai a riprendermelo. No, sembrava che nessuno fosse interessato. Da Budapest non sentii più nessuno e io mi dedicai a cercare di sbarcare il lunario. E non ho vergogna a ricordare che tante volte ho avuto il problema di mettere insieme il pranzo con la cena.
Così successe che, piano piano, me ne dimenticai anch’io. Ci pensavo spesso, naturalmente, ma cominciavo a dubitare. Mi dicevo: ma è veramente vero quello che mi ricordo? E’ vero quello che è successo agli ebrei di Budapest? E’ vero quello che ho fatto in quei mesi? Mi è capitato diverse volte di avere dei dubbi. Allora mi fermavo e mi dicevo: Giorgio, proviamo a rimettere insieme le date e le circostanze. Mi mettevo a ragionare e tutto tornava: le date, i luoghi, le persone. Non mi sbagliavo. Era veramente successo”.
E. Deaglio, La banalità del bene, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 13-20