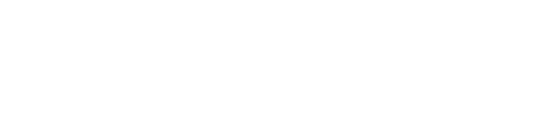Parigi, Drancy e Auschwitz
Nel 1940 fui congedato dall’esercito francese. La Francia, divisa in due zone – quella occupata e quella apparentemente non occupata -, venne in realtà sottomessa, anche nella parte cosiddetta libera, all’autorità dell’invasore. Suonò l’ora del governo di Pétain, di Laval, di Déat; tutti i bassifondi fascisti vennero a galla insieme alla loro sporca schiuma, contenti di poter nuotare nell’acqua torbida.
Seguendo le istruzioni del Partito, lasciai i Pirenei orientali per stabilirmi a Parigi, e ciò a dispetto dei manifesti affissi negli uffici di smobilitazione, che sconsigliavano ai meticci, agli ebrei e ai neri di soggiornare nelle zone occupate. Un giorno, mentre tornavo da una missione, la polizia francese e tedesca bloccò le uscite del metrò alla stazione Jean-Juarés, quindi condusse tutti i passeggeri, accompagnati da un’imponente scorta, al garage dell’avenue Simon Bolivar.
Ciascuno di noi dovette chiarire ai poliziotti le ragioni per le quali si era trovato in quel posto, a quell’ora, su quella linea della metropolitana. L’interrogatorio, tuttavia, non era che un pretesto poiché, senza tener conto delle spiegazioni, tutti gli uomini dai diciotto ai quarantacinque anni furono arrestati e, manette ai polsi, portati con i camioncini della polizia nella prigione di Cherche-Midi; quanto agli ebrei, vennero condotti verso il campo di transito, a Drancy, nei dintorni di Parigi. Io ero fra loro.
A Drancy sentii per la prima volta l’accusa avanzata dagli intellettuali israeliti francesi che erano stati arrestati, secondo i quali l’affluenza eccessiva in Francia di immigrati ebrei provenienti dall’Europa centrale e orientale era all’origine dell’antisemitismo. Erano convinti che, essendo integrati nel paese da generazioni, avessimo acquisito la mentalità delle alte sfere della società francese. In compenso, ritenevano, il nostro crimine consisteva nell’aver importato in Francia i nostri particolari costumi religiosi, il nostro gusto per il commercio, e nell’aver instaurato il ghetto, che comportava l’isolamento e innalzava una barriera, ostacolando l’assimilazione. Le assurde discussioni intorno a questi argomenti non facevano che suscitare rabbia e aggravare le divisioni, senza avere, evidentemente, nessuna influenza sul corso degli avvenimenti.
Dopo cinque giorni a Drancy, la maggioranza degli internati furono avviati – per lavorare, così ci veniva detto – verso una località sconosciuta, situata da qualche parte all’Est e che chiamavamo con macabro senso dell’umorismo Pitchi Poi. Per il viaggio, che durò alcuni giorni, ci sistemarono in carri bestiame piombati, ammassati a centinaia. C’erano donne, bambini e vecchi, ma mancavamo d’acqua e di latrine. Il pavimento dei vagoni era ricoperto di calce viva che, se entrava in contatto con un liquido, sprigionava delle emanazioni tossiche. Quando arrivammo a destinazione, nella località di Birkenau, vicino al confine con la Slesia polacca, eravamo semiasfissiati.
Non appena il treno si fermò, ci fecero uscire dai vagoni per procedere immediatamente alla selezione. Per ordine di un SS, un uomo anziano venne ucciso a manganellate perché portava sulla giacca una medaglia conferitagli dalle autorità militari francesi per la sua partecipazione alla battaglia di Verdun.
Terminata la selezione, gli uomini validi furono diretti verso il campo a passo di corsa. Quando poi venimmo spogliati di tutto ciò che avevamo con noi (i bagagli principali avevamo dovuto abbandonarli sulla rampa d’arrivo), quando non soltanto i portafogli e quanto avevamo in tasca, ma anche i documenti ci furono strappati dai sorveglianti, ci venne attribuito a titolo di ricompensa un numero, tatuato sull’avambraccio sinistro; da quel momento, avrebbe sostituito le nostre carte d’identità e avrebbe rappresentato il nostro unico bene. Poi, ci ammucchiarono nella baracca numero 9.
Quale non fu la mia sorpresa quando constatai che la persona preposta al comando dei settecento prigionieri del baraccamento, manganello alla mano, era il compagno Berger! Con il titolo ufficiale di scrivano del blocco (Blockschreiber), egli deteneva, in realtà, insieme a pochi altri, tutti i poteri che le autorità naziste erano disposte a concedere a un prigioniero. Sua signoria il Kapo, con la testa rasata, gli occhi stravolti pieni d’odio, la bava alla bocca, il viso sproporzionatamente allungato, brandiva senza sosta il manganello, simbolo del suo potere nel campo. Quando lo vidi, mi sentii paralizzato dalla paura; cosa potevo fare perché non mi riconoscesse? Non sapevo dove nascondermi.
Solo qualche giorno più tardi compresi tutta la portata dell’inferno in cui mi trovavo e il ruolo criminale che vi svolgeva il compagno Berger, insieme a uno stato maggiore di sorveglianti e di Kapo reclutati fra i detenuti appartenenti alla più volgare teppaglia. Una settimana dopo, parte dei prigionieri alloggiati nella sovrappopolata baracca numero 9 furono trasferiti, me compreso, nel vicino baraccamento numero 15. Da lì, potevo seguire più facilmente e in condizioni di maggior sicurezza l’attività del compagno Berger. All’inizio, non solo mi interessava, ma mi intrigava. Mi vergognavo per lui, mi sentivo in qualche modo corresponsabile dei suoi maneggi. La melma in cui era immerso sembrava inzaccherarmi. Durante gli appelli senza fine, i prigionieri delle due baracche si allineavano così vicini gli uni agli altri che potevo osservare Berger a mio piacimento.
Della sua boria, così evidente alle riunioni del Partito, non restava più niente; o piuttosto, si era trasformata in una bassa servilità verso i suoi nuovi superiori. Per soddisfare la sua superbia, dettata dalla passione per il comando e per il dominio, torturava e ammazzava i detenuti che avevano avuto la sfortuna di capitare sotto i suoi ordini, soprattutto quelli che facevano parte dei convogli appena arrivati. La sua crudeltà superava ogni limite quando aveva a che fare con gli olandesi e con gli ungheresi perché non ne conosceva la lingua. Durante il lavoro e nella baracca non perdeva occasione per malmenare gli uomini denutriti e indifesi. Sotto l’impulso delle autorità tedesche, quell’essere, senza stile né morale, debole di natura, divenne un mostro infame pronto all’azione più ignobile e spietata.
C. Liblau, I Kapos di Auschwitz, Torino, Einaudi, 2007, pp. 7-10. Traduzione di C. Testi