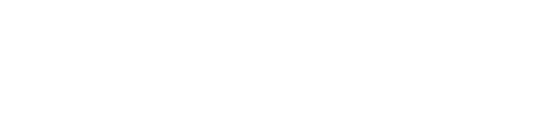Il compagno greco di Primo Levi
Si chiamava Mordo Nahum, e a prima vista non presentava nulla di notevole, salvo le scarpe (di cuoio, quasi nuove, di modello elegante: un vero portento, dato il tempo e il luogo), e il sacco che portava sul dorso, che era di mole cospicua e di peso corrispondente, come io stesso avrei dovuto constatare nei giorni che seguirono. Oltre alla sua lingua, parlava spagnolo (come tutti gli ebrei di Salonicco), francese, un italiano stentato ma di buon accento, e, seppi poi, il turco, il bulgaro e un po’ di albanese. Aveva quarant’anni: era di statura piuttosto alta, ma camminava curvo, con la testa in avanti, come i miopi. Rosso di pelo e di pelle, aveva grossi occhi scialbi ed acquosi e un gran naso ricurvo; il che conferiva all’intera sua persona un aspetto insieme rapace ed impedito, quasi di uccello notturno sorpreso dalla luce, o di pesce da preda fuori del suo naturale elemento.
Era convalescente di una malattia imprecisata, che gli aveva provocato accessi di febbre altissima, sfibrante; anche allora, nelle prime notti di viaggio, cadeva talvolta in uno stato di prostrazione, con brividi e delirio. Pur senza sentirci particolarmente attirati l’uno dall’altro, eravamo avvicinati dalle due lingue in comune, e dal fatto, assai sensibile in quelle circostanze, di essere i soli due mediterranei del piccolo gruppo. […]
Dietro sua perentoria richiesta, io mi ero caricato il famoso fardello. – Ma è roba tua! – avevo cercato invano di protestare. – Appunto perché è mia. Io la ho organizzata e tu la porti. E’ la divisione del lavoro. Più tardi ne profitterai anche tu –. Così ci incamminammo, lui primo ed io secondo, sulla neve compatta di una strada di periferia; il sole era tramontato.
Ho già detto delle scarpe del greco; quanto a me, calzavo un paio di curiose calzature quali in Italia ho visto portare solo dai preti: di cuoio delicatissimo, alte fin sopra il malleolo, senza legacci, con due grosse fibbie, e due pezze laterali di tessuto elastico che avrebbero dovuto assicurare la chiusura e l’aderenza. Indossavo inoltre ben quattro paia sovrapposte di pantaloni di tela da Häftlinge [= detenuto, prigioniero di un lager – n.d.r.], una camicia di cotone, una giacca pure a righe, e basta. Il mio bagaglio consisteva di una coperta e di una scatola di cartone in cui avevo prima conservato qualche pezzo di pane, ma ormai vuota: tutte cose che il greco sogguardava con non celato disprezzo e dispetto.
Ci eravamo ingannati grossolanamente sulla distanza da Cracovia: avremmo dovuto percorrere almeno sette chilometri. Dopo venti minuti di cammino, le mie scarpe erano andate: la suola di una si era staccata, e l’altra stava scucendosi. Il greco aveva conservato fino allora un silenzio pregnante: quando mi vide deporre il fardello, e sedere su di un paracarro per constatare il disastro, mi domandò:
- Quanti anni hai?
- Venticinque, risposi.
- Qual è il tuo mestiere?
- Sono chimico.
- Allora sei uno sciocco, mi disse tranquillamente. - Chi non ha scarpe è uno sciocco.
Era un grande greco. Poche volte nella mia vita, prima e dopo, mi sono sentito incombere sul capo una saggezza così concreta. C’era ben poco da replicare. La validità dell’argomento era palpabile, evidente: i due rottami informi ai miei piedi, e le due meraviglie lucenti ai suoi. Non c’era giustificazione. Non ero più uno schiavo: ma dopo i primi passi sulla via della libertà, eccomi seduto su un paracarro, coi piedi in mano, goffo e inutile come la locomotiva in avaria che da poco avevamo lasciata. Meritavo dunque la libertà? il greco sembrava dubitarne. […]
Mi spiegò che essere senza scarpe è una colpa molto grave. Quando c’è la guerra, a due cose bisogna pensare prima di tutto: in primo luogo alle scarpe, in secondo alla roba da mangiare; e non viceversa, come ritiene il volgo: perché chi ha le scarpe può andare in giro a trovar da mangiare, mentre non vale l’inverso. – Ma la guerra è finita, obiettai: e la pensavo finita, come molti in quei mesi di tregua, in un senso molto più universale di quanto si osi pensare oggi. - Guerra è sempre, - rispose memorabilmente Mordo Nahum. […] La sua vita era stata di guerra, e considerava vile e cieco chi rifiutasse questo suo universo di ferro. Era venuto il Lager per entrambi: io lo avevo percepito come un mostruoso stravolgimento, una anomalia laida della mia storia e della storia del mondo; lui, come una triste conferma di cose notorie. “Guerra è sempre”, l’uomo è lupo all’uomo: vecchia storia. Dei suoi due anni di Auschwitz non mi parlò mai.
Mi parlò invece, con eloquenza, delle sue molteplici attività in Salonicco, delle partite di merce comprate e vendute, contrabbandate per mare, o di notte attraverso la frontiera bulgara; delle frodi vergognosamente subite e di quelle gloriosamente perpetrate; e finalmente, delle ore liete e serene trascorse in riva al suo golfo, dopo la giornata di lavoro, con i colleghi mercanti, in certi caffè su palafitte che mi descrisse con inconsueto abbandono, e dei lunghi discorsi che quivi si tenevano. Quanti discorsi? Di moneta, di dogane, di noli, naturalmente; ma di altro ancora. Cosa abbia ad intendersi per conoscere, per spirito, per giustizia, per verità . Di quale natura sia il tenue legame che vincola l’anima al corpo, come esso si instauri col nascere, e si sciolga col morire. Cosa sia libertà, e come si concili il conflitto fra la libertà dello spirito e il destino. Cosa segua la la morte, anche: ed altre grandi cose greche. Ma tutto questo a sera, beninteso, a traffici ultimati, davanti al caffè o al vino o alle olive, lucido gioco di intelletto fra uomini attivi anche nell’ozio: senza passione.
Perché il greco raccontasse queste cose a me, perché si confessasse a me, non è chiaro. Forse, davanti a me così diverso, così straniero, si sentiva ancora solo, e il suo discorso era un monologo.
P. Levi, La tregua, Torino, Einaudi, 1965, pp. 43-44. 50-51. 63-65