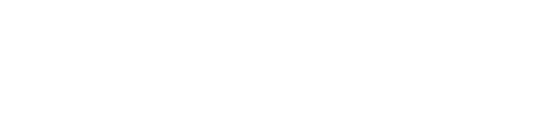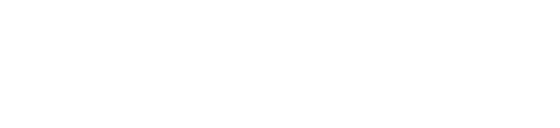L'evacuazione e la liberazione di Auschwitz
Gli ordini di Himmler
 Nell’estate del 1944, l’Armata Rossa compì una grande offensiva che la portò fino alla Vistola e, nella regione di Auschwitz, a circa 200 chilometri dal campo. I nazisti si resero conto della necessità di procedere in fretta all’evacuazione dei lager e cominciarono dal settore femminile di Birkenau: in settembre, una parte delle donne detenute fu trasferita a Ravensbrück, mentre le ammalate furono condotte (tra novembre e dicembre) a Bergen-Belsen. Alla fine di ottobre iniziarono i trasferimenti verso i lager della Germania dei detenuti ebrei maschi abili al lavoro: 2096 a Dachau, 1023 a Buchenwald, 2045 a Flossenbürg, 494 a Mauthausen, 2522 a Sachsenhausen e alcune centinaia a Stutthof. Il 30 ottobre, proveniente da Theresienstadt, arrivò l’ultimo convoglio di ebrei: dopo la selezione, dei 2038 deportati, 1689 furono condotti subito alle camere a gas.
Nell’estate del 1944, l’Armata Rossa compì una grande offensiva che la portò fino alla Vistola e, nella regione di Auschwitz, a circa 200 chilometri dal campo. I nazisti si resero conto della necessità di procedere in fretta all’evacuazione dei lager e cominciarono dal settore femminile di Birkenau: in settembre, una parte delle donne detenute fu trasferita a Ravensbrück, mentre le ammalate furono condotte (tra novembre e dicembre) a Bergen-Belsen. Alla fine di ottobre iniziarono i trasferimenti verso i lager della Germania dei detenuti ebrei maschi abili al lavoro: 2096 a Dachau, 1023 a Buchenwald, 2045 a Flossenbürg, 494 a Mauthausen, 2522 a Sachsenhausen e alcune centinaia a Stutthof. Il 30 ottobre, proveniente da Theresienstadt, arrivò l’ultimo convoglio di ebrei: dopo la selezione, dei 2038 deportati, 1689 furono condotti subito alle camere a gas.Nel novembre 1944, con una lucidità molto maggiore rispetto a Hitler, Himmler si rese conto che la guerra era perduta e si illuse di poter intavolare trattative con gli Alleati. Tra i meriti che pensava di poter avanzare, doveva esservi anche quello di aver posto fine allo sterminio degli ebrei. Pertanto, intorno al 28 novembre, Himmler emanò un ordine verbale che bloccava le gassazioni ad Auschwitz e di distruggere le tre strutture omicide di Birkenau rimaste ancora in funzione, dopo che il Sonderkommando, durante la rivolta del 7 ottobre 1944, aveva messo fuori uso il Crematorio IV. Quest’ultimo, nel corso del mese d’ottobre, fu completamente smantellato, fino alle fondamenta.
La distruzione dei crematori
In dicembre, per ottemperare agli ordini di Himmler, iniziarono le operazioni di distruzione dei grandi Crematori II e III. Gli impianti dei forni furono accuratamente smontati e spediti in Germania. Il Crematorio V restò in funzione, ma svolse solo funzioni sanitarie: distruggere i cadaveri dei detenuti morti all’interno del lager per gli stenti o per la fatica legata al lavoro. Quanto al Crematorio I del campo base, era già stata disattivato nel 1943 e privato delle installazioni interne alla metà del 1944. Il 17 gennaio 1945 ebbe luogo l’ultimo appello generale nel campo di Auschwitz. Erano presenti 67 012 detenuti (maschi e femmine): 31 894 ad Auschwitz I e a Birkenau, 35 118 nei sottocampi e a Monowitz. La mattina presto del giorno 18 gennaio, iniziò la partenza di coloro che erano in grado di camminare, divisi in colonne di diversa entità (500, 1000, 1500 individui, a seconda dei casi). Restarono circa 9000 malati, in una situazione di degrado e abbandono totale, che Primo Levi ricorda come un terribile incubo.
Tra il 20 e il 26 gennaio, le SS fecero saltare in aria quanto restava dei Crematori II e III, distrussero con la dinamite il Crematorio V (ancora intatto) e incendiarono il Kanada, il quartiere di baracche adibite a magazzino. Il 27 gennaio arrivarono le prime truppe sovietiche; come Levi non si stancò di ripetere, la liberazione non ebbe niente di festoso, ma fu accompagnata – in chi non era troppo malato o denutrito, per rendersi conto di quanto accadeva – da un insieme di sentimenti contrastanti: la consapevolezza dell’offesa subita, la vergogna per essere sopravvissuti, il rimorso per azioni immorali compiute durante la prigionia o per omissioni di soccorso nei confronti di compagni in difficoltà. In altri soggetti, il delirio, la follia o il mutismo totale denotavano che l’esperienza del lager li aveva completamente devastati; in tutti i superstiti, avrebbe lasciato segni profondi e del tutto indelebili.