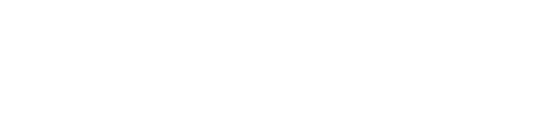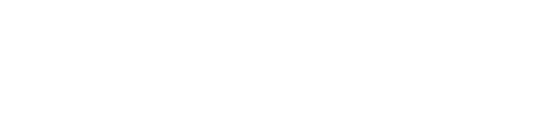Un prigioniero italiano al lavoro nell'impianto chimico
Seguimmo un primo tratto di strada piuttosto angusta compresa fra due reti di filo spinato sino a giungere ad un posto di polizia dove, dopo aver esibito i documenti di riconoscimento in nostro possesso, cioè l’Ausweis, passammo attraverso una porta rivestita di reticolato, trovandoci d’improvviso in un altro ambiente completamente differente.
“Das ist das grosse Werk”, mi annunciò l’agente che mi stava accompagnando: “questa è la grande opera, vale a dire: il grande complesso industriale”.
Questi particolari li ricordo nitidamente poiché tale itinerario, d’ora in avanti, avrei dovuto seguirlo giornalmente, al mattino nell’andata e la sera nel ritorno.
Proseguimmo ancora per tre, quattro chilometri finché, finalmente intravedemmo il massiccio edificio della fabbrica di carburo.
Prima che il mio accompagnatore ritornasse sui suoi passi, mi presentò al direttore: un certo ingegner Krüssfeld il quale, da vero tedesco, mi porse garbatamente la mano. Il dirigente, senza perdere tempo, mi accompagnò alla base di un’enorme struttura dove era stato ricavato una specie di corridoio, chiuso da porte alle due estremità: all’interno era disposto un lungo banco sul quale si trovavano allineati alcuni apparecchi di analisi. Mi presentò all’analista, il quale era di nazionalità slovacca, dicendo: “Der ist Ihr neurer Gehilfe” - questo è il suo nuovo aiutante, quindi, senza più aggiungere altre parole se ne andò salutando entrambi.
Dall’espressione del volto poco gioviale, lo slovacco non apparve molto soddisfatto del mio arrivo, tuttavia non aggiunse altre parole oltre a quelle strettamente necessarie. Il lavoro consisteva nell’analizzare sistematicamente i gas uscenti dai forni elettrici che producevano carburo di calcio e quelli che eventualmente si sarebbero formati nei tamburi di raffreddamento. […]
La fabbrica di carburo, il quale costituiva il prodotto di partenza per la produzione della gomma sintetica, distava sette chilometri dal campo n° 1; per arrivarci impiegavo un’ora e un quarto camminando con passo spedito ed altrettanto per ritornarci.
Partivo dal lager eins [= campo n° 1 – n.d.r.] alle cinque meno un quarto del mattino, in maniera di trovarmi sul posto di lavoro alle sei precise al momento del cambio di turno: lavoravo ininterrottamente fino a mezzogiorno in punto alla cui ora arrivava il portaviveri. Si fruiva di un’ora di sosta per consumare il pasto costituito dalla solita zuppa di patate bollite. Si riprendeva l’attività alle ore tredici, interrompendola alle diciotto. Ritornavo quindi al campo dove giungevo verso le diciannove e un quarto.
Come ebbi già occasione di parlarne, il lavoro da svolgere sebbene fosse importante ed impegnativo e, talvolta, risultasse rischioso, non era affatto pesante: ciononostante le ore durante le quali si rimaneva in movimento erano molte e pertanto, alla sera mi sentivo stanco e subito dopo il pasto sentivo la necessità di ritirarmi nella mia stube a riposare. In rare occasioni passavo a far quattro chiacchiere con l’amico ingegnere oppure con qualche compagno francese nel caso ci fosse stato da discutere su importanti argomenti di comune interesse. Io svolgevo il mio lavoro solo di giorno poiché, il turno di notte, era stato assegnato a due analisti tedeschi originari dei Sudeti.
Dal momento in cui incominciai a lavorare, alla mia porzione di cibo giornaliero, costituito, sino dal primo giorno del mio arrivo ad Auschwitz, da due pasti di zuppa di patate e 250 gr. Di pane, vennero aggiunti ogni settimana 60 gr. di zucchero, 50 gr. di marmellata rappresa in tavolette e 30 gr. di margarina. […]
Dopo una settimana che svolgevo la mia attività presso il laboratorio della fabbrica di carburo, un pomeriggio si presentò un signore alto di statura, segaligno ed elegantemente vestito, distinto nel portamento e dai lineamenti piuttosto duri e severi. Appariva talmente autoritario da sembrare un ufficiale prussiano in borghese: prussiano infatti lo era di nascita e di professione dottore in chimica e si chiamava Schlöttig. Era il direttore di tutti gli stabilimenti addetti alla produzione della gomma sintetica che i tedeschi chiamavano con il nome tecnico-commerciale di Buna. Si presentò infatti come nostro dirigente degli impianti Buna porgendoci la mano e raccomandandoci che da quel giorno facessimo in modo di consegnare, ogni sera, i dati di analisi dei gas uscenti dai forni elettrici della fabbrica all’ufficio di statistica allo scopo di giungere a constatarne la costanza della loro composizione nel tempo. […]
Fino all’inizio del mese di maggio [1944] non si verificarono fatti di importanza tale da essere ricordati, ma nel corso di tale mese i partigiani polacchi ripresero con rinnovato vigore le azioni di sabotaggio riuscendo a danneggiare seriamente una delle centrali termoelettriche. Di conseguenza, tutte le fabbriche della Buna rimasero inattive per una ventina di giorni. In questo periodo venni trasferito in un laboratorio che si trovava nei pressi del bureaux centrale dove lavoravano pure alcuni chimici ebrei.
Durante tutto il tempo della mia permanenza ad Auschwitz non ho mai saputo che Primo Levi fosse stato quivi deportato: ho avuto conoscenza di ciò solamente parecchio tempo dopo il mio rimpatrio. Egli era un chimico per cui, pensando a quel luogo, giurerei con molta convinzione che in tale occasione si trovasse presente in quel laboratorio. D’altra parte a noi era vietato tassativamente parlare con gli ebrei ed essi con noi e pertanto, era impossibile entrare in comunicazione in modo da potersi conoscere specie in un luogo chiuso.
Al laboratorio ebbi come compito quello di preparare su ricetta del tiofenilcarbanilide, prodotto che poteva essere usato anche come nebbiogeno. Siccome si aveva a disposizione una biblioteca fornitissima non era difficile trovare tutte le informazioni necessarie alla sua lunga preparazione.
Nello stesso periodo si intensificarono pure le azioni di bombardamento nell’ambito del Werk: gli americani di giorno e gli inglesi di notte. Questi ultimi, prima di sganciare dagli aerei il loro carico di bombe, illuminavano a giorno la zona con bengala, razzi che emettevano una luce bianco-vivida. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno ed ero ancora impegnato nel lavoro, quando iniziò il primo bombardamento di cui mantengo ancora nitido il ricordo. Prima si udirono gli aerei arrivare e quando incominciarono le deflagrazioni delle prime bombe sganciate dagli apparecchi, solamente allora si udirono i fischi delle sirene d’allarme, solo allora mi slanciai fuori all’aperto riuscendo a malapena a riparare in un rifugio fortunatamente poco distante, già occupato da impiegati tedeschi.
Il secondo bombardamento ebbe luogo verso la fine del periodo di permanenza nel laboratorio. In questo caso ebbi la possibilità di mettermi in salvo in un rifugio molto sicuro, tanto è vero che, ad un certo momento una bomba cadde proprio sulla soletta in calcestruzzo di grosso spessore e lo scoppio che ne seguì fu così acuto e fragoroso da avere l’impressione che il cranio andasse a pezzi. Tuttavia, al cessato allarme, uscimmo tutti indenni dal rifugio ma, subito dopo, ebbi la triste sorpresa di trovare il laboratorio completamente distrutto ed osservare, impotente, i libri di quella magnifica biblioteca scientifica in fiamme.
D. Santolini, Auschwitz. Ricordi di un Chimico, deportato politico Matricola 623973, Belvedere di Tezze (VI), Estroprint, 2006, pp. 50-54 e 60-64