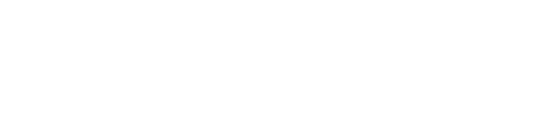L'organizzazione interna del campo
La vista della fortezza di Mauthausen fu impressionante. Venivamo dalla stazione coi bagagli e ci trovavamo davanti a una specie di gigantesca pagoda.
Avemmo tuttavia un attimo di illusione, perché gli uomini con l’uniforme zebrata che si mostrarono per primi non sembravano malmessi. Purtroppo non erano prigionieri come noi, ma kapò.
A costoro le SS affidavano l’esercizio della violenza continuata, l’arbitrio sulla vita dei sottoposti e l’organizzazione della disciplina. Dei supplenti, insomma, ai quali toccava un ruolo dispotico pur essendo a loro volta prigionieri e subalterni. Come spesso accade nelle strutture altamente punitive, chi ottiene un privilegio anche minimo è portato a difenderlo con ferocia. Immaginiamo questi kapò: criminali comuni per la maggior parte, tolti dalle carceri civili per trasformarsi in cani da guardia.
I tedeschi avevano stabilito le regole e, secondo il criterio della gerarchia militaresca, intendevano applicarle in forma socializzata: fecero così milioni di vittime, ma ebbero anche molti complici. La vita quotidiana del lager dipendeva quasi totalmente dai kapò e dalle loro specifiche funzioni: lageraltester, block-altester, arbeitskommando... [= prigionieri anziani, responsabili di un blocco, cioè di una baracca di detenuti, oppure incaricati di sorvegliare una squadra di lavoro – n.d.r.]. Poi c’erano altri prigionieri con incarichi particolari: gli scritturali (schreiber), gli infermieri (stubedin), i tosatori spagnoli chiamati friseur, che dovevano farci la strasse sul cranio, cioè il segno di riconoscimento (e d’infamia) che avrebbe compromesso qualunque tentativo di fuga.
Il lager somigliava insomma ad una caserma; ne rifletteva un’immagine deformata. Ai kapò spettava la crudeltà della disciplina, alle altre figure un ruolo di servizio.
Nel breve periodo di Bolzano le SS ci stavano addosso; ricordo un giovane di Parma, Barbieri, che fu bastonato perché al richiamo dell’ufficiale non era scattato come prescriveva la norma: idiot! gli gridò il comandante nel vederlo con le mani in tasca, e fece venire un subalterno con la verga. A Mauthausen, invece, la presenza delle SS indicava l’apice della gerarchia, raffigurava l’inaccessibilità, la sacralità del comando. Nel perimetro del lager le SS si vedevano raramente, erano alloggiate in appositi fabbricati fuori del muro di cinta. Chiunque, davanti a uno di loro, doveva togliersi il berretto e nessuno, tra i prigionieri come me, poteva parlare direttamente.
L’SS interveniva a scadenze regolari lungo la giornata e la notte – per esempio agli appelli, alle selezioni – o quando si celebrava un rito esemplare. In quella occasione tutti i prigionieri dovevano sapere e vedere chi fosse sul gradino più alto. Durante gli appelli, almeno due volte al giorno, qualcuno cadeva a terra sfinito. Loro passavano contando: morto, malato, camera a gas... Diverse volte li ho guardati negli occhi per indovinare odio o disprezzo... Niente, nessun sentimento. Sembrava trattassero mattoni o carbone. Eravamo stück, merce.
(P. Iotti con T. Masoni, Sono dov’è il mio corpo. Memoria di un ex deportato a Mauthausen, Firenze, Giuntina, 1995, pp. 30-32).