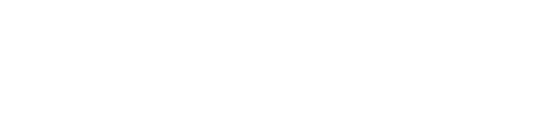La deportazione degli ebrei stranieri
Lo chiamavano Moshé lo Shammàsh [ = inserviente – n.d.r.], come se dalla vita non avesse avuto un cognome. Era il factotum di una sinagoga chassidica [= il chassidismo era un movimento mistico, sorto in Europa orientale nel XVIII secolo – n.d.r.]. Gli ebrei di Sighet – questa piccola città della Transilvania dove ho trascorso la mia infanzia – gli volevano molto bene. Era molto povero e viveva miseramente. Di solito gli abitanti della mia città, anche se aiutavano i poveri, non è che li amavano tanto: Moshé lo Shammàsh faceva eccezione. Non dava fastidio a nessuno, la sua presenza non disturbava nessuno. Era diventato maestro nell’arte di farsi insignificante, di rendersi invisibile. […]
Poi un giorno, gli ebrei stranieri vennero espulsi da Sighèt. E Moshè lo Shammash era straniero. Stipati dai gendarmi ungheresi nei carri bestiame piangevano sommessamente. Sul marciapiede di partenza piangevamo anche noi. Il treno scomparve all'orizzonte, lasciando dietro di sé soltanto un fumo spesso e sporco. Sentii un ebreo sospirare alle mie spalle: - Che volete? E' la guerra...
I deportati vennero presto dimenticati. Alcuni giorni dopo la loro partenza si diceva che si trovassero in Galizia, dove lavoravano, e anche che erano soddisfatti della loro sorte. Passarono giorni, settimane, mesi. La vita era tornata normale. Un vento calmo e rassicurante soffiava dappertutto. I commercianti facevano buoni affari, gli studenti vivevano in mezzo ai libri e i bambini giocavano nelle strade.
Un giorno, mentre stavo per entrare in sinagoga, vidi, seduto su una panca vicino alla porta, Moshé lo Shammàsh. Raccontò la sua storia e quella dei suoi compagni. Il treno dei deportati aveva varcato la frontiera ungherese e, in territorio polacco, era stato preso in carico dalla Gestapo. Là si era fermato. Gli ebrei dovettero scendere e montare su degli autocarri. Gli autocarri li portarono in una foresta dove li fecero di nuovo scendere. Poi fecero loro scavare delle grandi fosse. Appena finito quel lavoro, gli uomini della Gestapo cominciarono il loro. Senza passione, senza odio, abbatterono tutti i prigionieri. Ognuno doveva avvicinarsi alla buca e presentare la nuca.
I neonati venivano gettati per aria a far da bersaglio ai mitra. Questo accadeva nella foresta di Galizia, presso Kolomaye. Com'è che lui, Moshè lo Shammash, era riuscito a salvarsi? Per un miracolo. Ferito a una gamba, lo credettero morto...
Per giorni e notti andava da una casa ebraica all'altra, e raccontava la storia di Malka, la ragazza che agonizzò per tre giorni, e quella di Tobia, il sarto, che implorava che lo uccidessero prima dei suoi figli... Era cambiato, Moshè. I suoi occhi non riflettevano più la gioia. Non cantava più. Non mi parlava più di Dio, ma solamente di ciò che aveva visto. La gente non solo si rifiutava di credere alle sue storie, ma anche di ascoltarle. - Cerca di farci provare pietà per la sua sorte. Che immaginazione... Oppure: - Poveretto, è diventato matto.
E lui piangeva: - Ebrei, ascoltatemi. E' tutto ciò che vi chiedo. Non soldi, non pietà, ma che voi mi ascoltiate - gridava nella sinagoga, fra la preghiera del crepuscolo e quella della sera.
Anch'io non gli credevo. Mi sedevo spesso accanto a lui la sera, dopo la funzione e ascoltavo le sue storie, facendo ogni sforzo per comprendere la sua tristezza. Avevo soltanto pietà di lui.
- Mi prendono per matto - mormorava, e le lacrime, come gocce di cera, gli colavano dagli occhi.
Una volta gli domandai: - Perché vuoi assolutamente che si creda a ciò che dici? Al tuo posto la cosa mi lascerebbe indifferente, che mi si creda o no...
Lui chiuse gli occhi, come per fuggire il tempo: - Tu non capisci - disse con disperazione. - Tu non puoi capire. Sono salvo per miracolo, sono riuscito a tornare fin qui. Da dove ho preso questa forza? Ho voluto tornare a Sighèt per raccontarvi la mia morte, perché possiate prepararvi finché c'è ancora tempo. Vivere? Non ci tengo più alla vita. Sono solo. Ma sono voluto tornare, e avvertirvi. Ed ecco che nessuno mi ascolta.
Questo accadeva verso la fine del 1942.
E. Wiesel, La notte, Firenze, Giuntina, pp. 11-15. Traduzione di D. Vogelmann