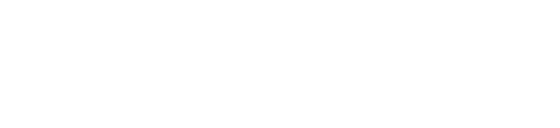La partenza degli ebrei di Sighet
Alle nove, [...] gendarmi con i manganelli che urlavano: “Tutti gli ebrei fuori!”.
Noi eravamo pronti. Io uscii per primo. Non volevo guardare in faccia i miei genitori. Non volevo scoppiare in lacrime. Restammo seduti in mezzo alla strada, come gli altri del giorno prima. Lo stesso sole infernale. La stessa sete. Ma non c’era più nessuno per portarci dell’acqua.
Contemplavo la nostra casa, dove avevo passato degli anni a cercare il mio Dio, a digiunare per affrettare la venuta del Messia, a immaginare quella che sarebbe stata la mia vita. Ma non ero molto triste: non pensavo a nulla.
- In piedi! Appello!
In piedi. Ci contano. Seduti. Ancora in piedi. Di nuovo per terra. Senza fine. Attendevamo con impazienza che ci portassero via. Che si aspettava? L’ordine infine arrivò: “Avanti!”.
Mio padre piangeva. Era la prima volta che lo vedevo piangere. Non mi ero mai immaginato che sarebbe potuto succedere. Mia madre, lei, marciava, il volto chiuso, senza esprimere una parola di preoccupazione. Io guardavo la mia sorellina, Zipporà, i suoi capelli biondi ben pettinati, un cappotto rosso sul braccio: una bambina di sette anni. Sulle spalle, un sacco troppo pesante per lei. Serrava i denti: sapeva già che lamentarsi non serviva a nulla. I gendarmi distribuivano qua e là colpi di manganello: “Più svelti!”. Io non avevo più forze. Il cammino era appena agli inizi e io mi sentivo già così debole…
- Più svelti! Più svelti! Avanti, sfaticati! – urlavano i gendarmi ungheresi.
E’ in quel momento che ho cominciato a odiarli, e il mio odio è l’unica cosa che ci lega ancora oggi. Erano i nostri primi oppressori, erano il primo volto dell’inferno e della morte.
Ci ordinarono di correre. Prendemmo il passo di corsa. Chi avrebbe creduto che eravamo così forti? Da dietro le loro finestre, da dietro le loro imposte, i nostri compatrioti ci guardavano passare. […]
Il nostro convoglio prese la direzione della grande sinagoga. La città sembrava deserta, ma, dietro le imposte, i nostri amici di ieri attendevano senza dubbio il momento di poter saccheggiare le nostre case.
La sinagoga somigliava a una grande stazione: bagagli e lacrime. L’altare era spezzato, i tappeti strappati, i muri spogliati. Noi eravamo così numerosi che potevamo appena respirare: che spaventose ventiquattr’ore passammo. Gli uomini erano al pianterreno, le donne al primo piano, ed era sabato: si sarebbe detto che eravamo venuti ad assistere alle funzioni. Non potendo uscire, la gente faceva i propri bisogni in un angolo.
L’indomani mattina marciammo verso la stazione, dove ci attendeva un convoglio di carri bestiame. I gendarmi ungheresi ci fecero montare in ragione di ottanta persone per carro. Ci lasciarono qualche pagnotta e qualche secchio d’acqua. Controllarono le sbarre delle finestre per vedere se tenevano bene. I carri vennero chiusi. Per ciascuno di essi era stato nominato un responsabile: se qualcuno scappava, è lui che avrebbero fucilato.
Sul marciapiede camminavano due ufficiali della Gestapo, tutti sorridenti: in complesso era andato tutto bene.
Un fischio prolungato perforò l’aria. Le ruote si misero a sferragliare. Eravamo in cammino.
E. Wiesel, La notte, Firenze, Giuntina, 1986, pp. 25-29. Traduzione di D. Vogelmann