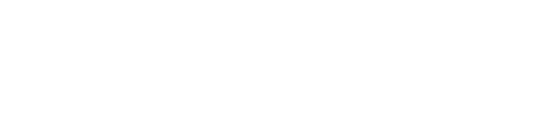Il Campo di Westerbork
Che cosa dovrei propriamente raccontare sulla vita di Westerbork?
Era estate quando vi giunsi. Fino a quel momento, del Drenthe io sapevo solo che c’erano molti dolmen e nient’altro: ora ci trovavo un villaggio di baracche di legno incorniciato da cielo e brughiera, con un campo di lupini straordinariamente gialli nel mezzo e tutt’intorno filo spinato. Laggiù si poteva trovare una grande abbondanza di vite umane. A dire la verità, io non avevo mai saputo che un certo numero di tedeschi fossero confinati già da quattro anni su quella brughiera del Drenthe, allora ero troppo occupata a raccoglier fondi per bambini spagnoli e cinesi.
In quei primi giorni giravo per il campo come se stessi sfogliando le pagine di un libro di storia. Incontrai persone che erano già state a Buchenwald e Dachau, quando questi nomi erano ancora suoni lontani e minacciosi per noi.
Incontrai persone che avevano girato il mondo su quella nave [= il piroscafo Saint Louis, salpato da Amburgo nel 1939, pieno di ebrei fuggitivi dalla Germania, che nessuno Stato volle ospitare sul proprio territorio – n.d.r.] che non aveva avuto il permesso di approdare in nessun porto: ve ne ricorderete di certo, a quel tempo i nostri giornali erano pieni di quella storia. [...] In breve, era come trovarsi davanti a un pezzetto tangibile del destino ebraico degli ultimi dieci anni: e c’era chi aveva creduto che nel Drenthe esistessero soltanto dei dolmen. Era quasi da togliere il fiato. [...]
Coloro a cui è toccato lo snervante privilegio di poter rimanere a Westerbork “fino a nuovo ordine”, corrono un grave rischio morale: quello di diventare apatici e insensibili.
Il dolore umano che abbiamo visto laggiù nel corso di quest’ultimo mezzo anno, e che vi si può ancora vedere ogni giorno, è più di quanto un individuo sia in grado di assorbire in un periodo così limitato. Del resto, lo sentiamo dire ogni giorno e in tutti i toni: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo dimenticare il più possibile”. E questo mi sembra molto pericoloso.
Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili. Ma forse possediamo altri organi oltre la ragione, organi che allora non conoscevamo, e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante.
Io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che gli consente di superarlo.
Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li ospitiamo e nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione -, allora non siamo una generazione vitale.
Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei; ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient’altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione -, allora non basterà. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo spinato, e congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena, e in circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una comune e onesta ricerca di chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti.
Per questo mi sembrava così pericoloso sentir ripetere: “Non vogliamo pensare, non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, la cosa migliore è diventare insensibili a tutta questa miseria”.
Come se il dolore – in qualunque forma ci tocchi incontrarlo – non facesse veramente parte dell’esistenza umana. [...]
In pochi mesi la popolazione di Westerbork si è gonfiata da 1000 a circa 10 000 unità. La crescita maggiore risale ai terribili giorni d’ottobre - quando in seguito a una grande caccia all’ebreo per tutta l’Olanda, il campo fu devastato da un’inondazione umana che minacciò di inghiottirlo. [...]
In questo campo di concentramento la mancanza di spazio è senza dubbio la carenza più grave. Circa 2500 persone su 10 000 sono alloggiate nelle 215 casette che un tempo costituivano il nucleo del campo, e che prima delle deportazioni erano tutte abitate da singole famiglie. [...] Adesso gli abitanti delle casette sono alloggiati in modo principesco, per essere a Westerbork, e sono invidiati e sempre assediati dagli altri.
La grande, la vergognosa miseria del campo incomincia nelle colossali baracche costruite in tutta fretta – in quelle rimesse di assi piene di spifferi e gremite di uomini, dove le cuccette di ferro a tre piani si ammassano sotto un cielo incombente di panni che centinaia di persone hanno steso ad asciugare.
Quei poveri francesi non avrebbero mai sospettato che sugli stessi letti da loro costruiti per la linea Maginot ebrei esiliati in una qualche brughiera del Drenthe avrebbero sognato i loro sogni spaventosi. Ho infatti saputo che quei letti provengono dalla linea Maginot.
Ora su quelle cuccette si vive e si muore, si mangia, si è malati, o non si riesce a dormire perché tanti bambini piangono durante la notte – o perché ci si continua a chiedere come mai non arrivino quasi notizie dalle molte migliaia già partite dal campo.
Sotto i letti sono sistemate le valigie, alle sbarre di ferro appesi gli zaini: gli unici ripostigli che abbiamo. Le altre suppellettili consistono di tavole di legno grezzo e strette panche di legno.
Delle condizioni igieniche preferisco non parlare nella mia modesta relazione, così Vi eviterò momenti poco gradevoli.
Qua e là per quei vasti ambienti ci sono delle stufe: bastano appena per riscaldare le vecchiette che, strette l’una all’altra, vi siedono intorno. Non ci è ancora troppo chiaro come si dovrà vivere in queste baracche durante l’inverno. [...]
E così crederete che io abbia raccontato qualcosa su Westerbork, con la mia lunga chiacchierata? Se provo a ricreare questo Westerbork davanti al mio occhio interiore – in tutte le sue sfaccettature e storia movimentata, in tutte le sue necessità spirituali e materiali –, allora so di non esserci riuscita affatto. E poi, il mio è un resoconto molto parziale. Potrei immaginarne un altro pieno di odio, amarezza e ribellione.
Ma la ribellione che nasce solo quando la miseria comincia a toccarci personalmente non è vera ribellione, e non potrà mai dare buoni frutti.
E assenza d’odio non significa di per sé assenza di un elementare sdegno morale. So che chi odia ha fondati motivi per farlo. Ma perché dovremmo sempre scegliere la strada più corta e a buon mercato? Laggiù ho potuto toccare con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più inospitale.
E credo anche, forse ingenuamente ma ostinatamente, che questa terra potrebbe ridiventare un po’ più abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel tredicesimo capitolo della sua prima lettera.
E. Hillesum, Lettere 1942-1943, Milano, Adelphi, 1990. pp. 35-36 e 44-51. Traduzione di C. Passanti