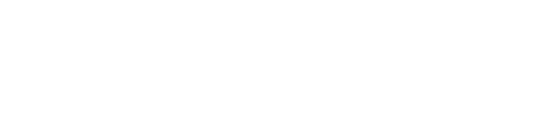Il resoconto di Liliana Segre
Cosa ricorda della marcia della morte?
La marcia è molto difficile da ricordare. È stata una cosa inimmaginabile. Migliaia e migliaia di esseri stremati che si trascinavano nella neve come automi. La strada disseminata di cadaveri, donne, uomini morti per lo sfinimento, per il freddo, o finiti dai soldati della scorta con una fucilata alla testa. Io non li guardavo, andavo avanti, un passo dopo l’altro, come ubriaca, perché volevo vivere, non volevo morire. Come le altre mi gettavo sugli immondezzai nella speranza di racimolare un torsolo di cavolo, una buccia di patata, una cosa qualsiasi da rosicchiare. Era una follia. Anche voler vivere era una follia. Avevamo già perso da mesi i freni inibitori. Se avevi un bisogno fisico, poteva esserci chiunque davanti a te, ti accovacciavi al bordo della strada, facevi quello che dovevi fare e proseguivi. Ero già prigioniera da un anno, e un anno ad Auschwitz ti cambia enormemente. Camminavamo, nevicava, ricordo come dei flash, però non una continuità. Non saprei dire né quanti giorni né quante notti sia durata. La prima volta che ci siamo fermate eravamo in una stazione bombardata, il tetto mezzo aperto. Eravamo in cinquantaseimila a fare la marcia della morte. Questo l’ho letto poi, perché certo allora non lo sapevo. Ci facevano camminare soprattutto di notte, perché i civili non dovevano vederci. Quando passavamo nei paesi c’era l’oscuramento, la gente doveva tenere le finestre chiuse, le porte chiuse.
Però ricordo che una volta siamo passati per un paese in pieno giorno, c’erano dei curiosi che guardavano, e le guardie gridavano, non avvicinatevi, questi hanno più di voi, non hanno bisogno dinulla! Non che ci volessero dare qualcosa, figurarsi, erano solo dei curiosi che guardavano le file enormi che attraversavano il loro paesino. Eravamo dei tali spaventi di persone che credo che persino i civili tedeschi potessero notare come eravamo ridotti. Eppure le guardie sbraitavano, non avvicinatevi, questi non hanno bisogno di niente, stanno benissimo!
Dove si trovava?
Chi lo sa? Ho fatto la marcia della morte senza sapere dove fossi. Dopo l’ho vista sulla carta geografica, ma allora non sapevo. Camminavo, vedevo nomi che non mi dicevano niente, che dimenticavo subito dopo aver letto. Poi mi ricordo che abbiamo percorso un tratto su un treno merci, con i vagoni scoperti, sotto la neve che fioccava, pigiate l’una contro l’altra, e alla mattina ci scrollavamo di dosso i cadaveri, tutti coperti da un sottile strato di ghiaccio. Essere pressate, per quanto orribile, ci ha salvato, perché il corpo umano emana un certo calore, altrimenti saremmo morte assiderate. Tutte, alla mattina, avevamo una crosticina di ghiaccio sopra alle divise, e poi c’erano quelle dure, morte. Siamo scese saltando giù da questo vagone, contente di aver fatto un pezzo col treno e non a piedi…
La marcia della morte vera e propria è stata quella da Auschwitz fino a Ravensbrück, quello è stato lo spostamento epocale, ma dopo ce ne sono stati altri, più piccoli. Ci spostavano sempre più a nord, man mano che si avvicinava il fronte. Ricordo che un’altra volta eravamo su un treno vero, un treno passeggeri, con i sedili di legno, ma neanche lì sapevo dove fossi. I miei ricordi sono vaghissimi, sia per la mia assoluta ignoranza della geografia che per il disinteresse che mi dominava; ero conscia solo della fatica tremenda, dei morti, dei colori della marcia, quello sì, ma non di dove fossi, né di chi ci fosse con me. Ricordo soltanto che ero con Luciana Sacerdote.
D. Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz, Milano, Bompiani, 2004, pp. 36-38