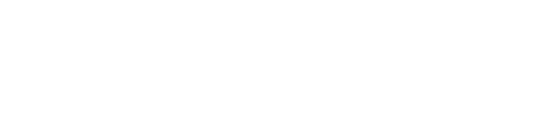Il resoconto di Elie Wiesel
La porta del capannone si aprì. Apparve un vecchio, i baffi coperti di brina, le labbra blu per il freddo. Era Rabbi Eliahu, il rabbino di una piccola comunità polacca. Un uomo molto buono, che tutti amavano al campo, anche i kapò e i capiblocco. Malgrado le prove e le sofferenze il suo volto continuava a riflettere la sua purità interiore. Era il solo rabbino che non dimenticavo mai di chiamare rabbì a Buna. Assomigliava a uno di quei profeti di un tempo, sempre in mezzo al popolo per consolarlo. E, fatto strano, le sue parole di consolazione non irritavano nessuno. Esse calmavano veramente.
Entrò nel capannone e i suoi occhi, più brillanti che mai, sembravano cercare qualcuno: “Forse avete visto mio figlio da qualche parte?”. Aveva perso il figlio nella ressa. Lo aveva cercato invano fra gli agonizzanti, poi aveva grattato via la neve per ritrovare il suo cadavere, ma senza risultato.
Per tre anni avevano resistito insieme: sempre l’uno accanto all’altro, per le sofferenze, per i colpi, per la razione di pane e per la preghiera. Tre anni, di campo in campo, di selezione in selezione. E adesso, quando la fine sembrava vicina, il destino li separava. Arrivatomi vicino Rabbi Eliahu mormorò: “E’ accaduto sulla strada. Ci siamo persi di vista durante il cammino. Io ero rimasto un po’ indietro: non avevo più la forza di correre. E mio figlio non se n’era accorto. Non so altro. Dov’è andato a finire? Dove posso ritrovarlo? Forse l’avete visto da qualche parte?”.
“No, Rabbi Eliahu, non l’ho visto”. Allora se ne è andato come era venuto, come un’ombra spazzata dal vento. Aveva già varcato la porta quando improvvisamente mi ricordai che avevo visto suo figlio correre accanto a me. L’avevo dimenticato e non l’avevo detto a Rabbi Eliahu!
Poi però mi ricordai un’altra cosa: il figlio aveva visto il padre perdere terreno, finire zoppicando in fondo alla colonna. L’aveva visto e aveva continuato a correre in testa, lasciando che la distanza fra di loro aumentasse. Un pensiero terribile mi venne in testa: aveva voluto sbarazzarsi di suo padre! Lo aveva visto in difficoltà, aveva creduto che ormai fosse la fine e aveva cercato quella separazione per togliersi di dosso quel peso, per liberarsi di un fardello che poteva diminuire le proprie possibilità di salvezza. Avevo fatto bene a dimenticarmelo, ed ero felice che Rabbi Eliahu continuasse a cercare il suo adorato figlio. Allora, mio malgrado, una preghiera si è risvegliata nel mio cuore, verso quel Dio a cui non credevo più: “Dio mio, Signore dell’Universo, dammi la forza di non fare mai quello che ha fatto il figlio di Rabbi Eliahu”.
Delle grida si levarono da fuori, nella corte, dove era scesa la notte. Le SS ordinavano di riformare i ranghi. Riprendemmo la marcia. I morti restarono nella corte, sotto la neve, come fedeli guardie assassinate, senza sepoltura. Nessuno aveva recitato per loro la preghiera dei morti. Figli abbandonarono le spoglie dei padri senza una lacrima. Sulla strada nevicava, nevicava, nevicava senza fine. Marciavamo più lentamente. Anche i guardiani sembravano stanchi. Il mio piede ferito aveva cessato di farmi male, doveva essere completamente gelato. Era perduto per me quel piede, si era staccato dal mio corpo come una ruota da una macchina. Tanto peggio. Bisognava farsene una ragione: sarei vissuto con una gamba sola. L’essenziale era non pensarci; soprattutto non in quel momento. Lasciare i pensieri per dopo.
La nostra marcia aveva perso ogni parvenza di disciplina. Ognuno andava come voleva, come poteva. Non si sentivano più spari: anche i nostri guardiani dovevano essere stanchi. Ma la morte non aveva molto bisogno di aiuto. Il freddo faceva coscienziosamente il suo lavoro. A ogni passo qualcuno crollava, cessava di soffrire. Ogni tanto ufficiali delle SS in motocicletta discendevano la colonna per scuotere la crescente apatia: “Forza! Stiamo arrivando! – Coraggio! Ancora poche ore! – Stiamo arrivando a Gleiwitz!”.
Queste parole di incoraggiamento, pur venendo dalle bocche dei nostri assassini, ci facevano un gran bene. Adesso nessuno voleva più arrendersi: proprio prima della fine, così vicini all’arrivo. I nostri occhi scrutavano l’orizzonte alla ricerca dei reticolati di Gleiwitz. Il nostro unico desiderio era quello di arrivarci prima possibile.
Era notte fonda. La neve smise di cadere. Marciammo ancora parecchie ore prima di arrivare. Scorgemmo il campo solo quando ci trovammo davanti alla porta.
E. Wiesel, La notte, Firenze, Giuntina, 1980, pp. 89-92. Traduzione di D. Vogelmann