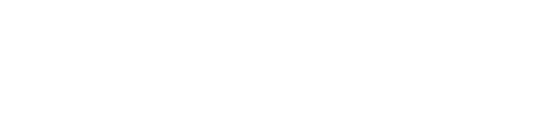La mediazione dell'azione e l'invisibilità delle vittime
Alcuni anni fa John Lachs individuò nella mediazione dell’azione (il fenomeno per cui l’azione di un individuo viene svolta in sua vece da qualcun altro, da un intermediario che <<si colloca tra me e la mia azione, rendendomi impossibile esperirla direttamente>> ) uno degli aspetti più significativi e tipici della società moderna. Esiste una grande distanza tra intenzioni e risultati pratici, distanza che viene colmata da tutta una serie di microazioni e di attori irrilevanti. Nel caso dell’uomo medio gli esiti dell’azione vengono espulsi dal campo visivo dell’attore.
<<Ne deriva che vi sono molte azioni di cui nessuno è consapevolmente responsabile. Per la persona a nome della quale esse vengono eseguite, tali azioni esistono solo a livello verbale o immaginario; questa persona non le riconoscerà come proprie, non avendole mai compiute direttamente. L’individuo che di fatto le ha eseguite, d’altra parte, le vedrà sempre come appartenenti a qualcun altro e considererà se stesso come un semplice strumento innocente di una volontà estranea…
Senza un rapporto diretto con le proprie azioni, anche il migliore degli esseri umani si muove in un vuoto morale: il riconoscimento astratto del male non costituisce né una guida affidabile, né una motivazione adeguata […]. È difficile accettare il fatto che spesso non esiste una persona o un gruppo che abbia pianificato o determinato un certo esito. Ed è ancora più difficile vedere come le nostre azioni, attraverso i loro effetti remoti, abbiano contribuito a causare la sofferenza >>.
L’aumento della distanza fisica e/o psichica tra l’azione e le sue conseguenze produce qualcosa di più che la sospensione dell’inibizione morale: esso annulla il significato morale dell’azione e con ciò previene ogni conflitto tra lo standard personale dell’accettabilità morale e l’immoralità delle conseguenze sociali dell’azione. Quando la maggior parte delle azioni sociologicamente significative viene mediata da una lunga catena di complessi rapporti di dipendenza causale e funzionale, i dilemmi morali scompaiono dalla vista e le occasioni di scrutinio e di scelta morale consapevole diventano sempre più rare.
Un effetto analogo (su scala ancora più impressionante) si ottiene rendendo le vittime stesse psicologicamente invisibili. Questo è stato certamente uno dei fattori più rilevanti responsabili dell’escalation dei costi umani nella guerra moderna. Come ha osservato Philip Caputo, l’ethos della guerra <<sembra essere una questione di distanza e di tecnologia. Non si può avere torto uccidendo la gente da lontano con armi sofisticate>>. Nell’uccisione <<a distanza>> il legame tra una carneficina e un’azione del tutto innocente – come premere un grilletto, o girare un interruttore della corrente elettrica o battere un tasto sulla tastiera di un computer – è destinato a rimanere una nozione puramente teorica (questa tendenza viene poi enormemente favorita dalla discrepanza di scala tra l’esito e la sua causa immediata, un’incommensurabilità che impedisce facilmente la comprensione basata sull’esperienza del senso comune).
È pertanto possibile essere un pilota che sgancia bombe su Hiroshima o su Dresda, eccellere nei compiti svolti in una base di missili teleguidati, o progettare modelli di armi nucleari sempre più devastanti, senza per questo perdere nulla della propria integrità morale e arrivare a una qualche crisi etica (l’invisibilità delle vittime fu, presumibilmente, un importante fattore anche nei tristemente noti esperimenti di Milgram).
Avendo presente l’effetto dell’invisibilità delle vittime, è forse più facile comprendere i perfezionamenti successivi apportati alla tecnologia dell’Olocausto. Nella fase delle Einsatzgruppen le vittime rastrellate venivano condotte di fronte alle mitragliatrici e uccise con il tiro diretto. Sebbene ci si sforzasse di tenere le armi il più lontano possibile dalle fosse in cui gli assassinati dovevano cadere, era troppo difficile per coloro che facevano fuoco ignorare il legame tra lo sparare e l’uccidere. Per tale ragione gli amministratori del genocidio trovavano questo metodo primitivo e inefficiente, oltre che pericoloso per la coscienza morale degli esecutori. Vennero perciò cercate altre tecniche di assassinio, tali da nascondere le vittime alla vista degli uccisori. La ricerca ebbe successo e portò all’invenzione delle camere a gas, dapprima mobili e poi fisse; queste ultime – le più perfette che i nazisti ebbero il tempo di inventare – riducevamo il ruolo dell’uccisore a quello di un ufficiale sanitario, al quale si chiedeva di introdurre una certa quantità di disinfettanti chimici attraverso un’apertura nel tetto di un edificio il cui interno egli non era tenuto a visitare.
Il successo tecnico-amministrativo dell’Oolocausto fu dovuto in parte alla sapiente utilizzazione dei tranquillanti morali messi a disposizione dalla tecnologia e dalla burocrazie moderne. Tra essi i più importanti furono la naturale invisibilità delle connessioni causali interne a un sistema di interazione complesso, e la collocazione a distanza degli esiti sgradevoli e moralmente ripugnanti dell’azione, fino al punto di renderli invisibili all’attore. I nazisti, tuttavia, si mostrarono particolarmente abili nell’utilizzazione di un terzo metodo, neanche questo di loro invenzione ma da essi portato a un grado di perfezionamento senza precedenti. Tale metodo consisteva nel rendere invisibile la stessa umanità delle vittime. Il concetto di universo degli obblighi sviluppato da Helen Fein (<<la cerchia di persone legate tra loro da obblighi di reciproca protezione, i cui vincoli derivano dal comune rapporto con una divinità o una fonte consacrata di autorità>>) contribuisce in misura significativa a illuminare i fattori socio-psicologici che sono alla base della terrificante efficacia di questo metodo. L’universo degli obblighi designa i confini esterni del territorio sociale all’interno del quale possono essere poste questioni morali dotate di senso. Al di là di tali confini i precetti morali non sono vincolanti e i giudizi morali risultano privi di senso. Per rendere invisibile l’umanità delle vittime è sufficiente espellere queste ultime dall’universo degli obblighi. […]
Dopo che l’obiettivo di una Germania judenfrei [= priva di ebrei – n.d.r.] si era trasformato in quello di un’Europa judenfrei, l’espulsione degli ebrei dalla nazione tedesca doveva essere sostituita dalla loro totale disumanizzazione. Di qui l’associazione, prediletta da Frank [= Hans Frank, governatore generale della Polonia occupata – n.d.r.], tra <<ebrei e pidocchi>>, il cambiamento di registro retorico espresso dallo spostamento della questione ebraica dal contesto dell’autodifesa razziale all’universo linguistico della pulizia personale e dell’igiene politica, i manifesti contro il tifo attaccati sui muri dei ghetti e, infine, l’ordinazione dei prodotti chimici [= lo Zyclon B – n.d.r.] necessari per l’atto finale alla Gesellschaft für Schädlingsbekämpung, la Società tedesca per la lotta contro i parassiti.
Z. Bauman, Modernità e Olocausto , Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 45-48. Traduzione di M. Baldini