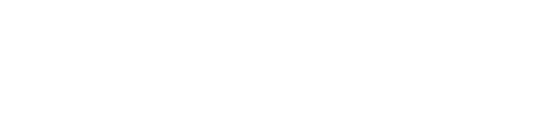Dimensioni e caratteri della violenza staliniana
Nell’URSS staliniana la violenza di massa esercitata dal regime si volse verso l’interno, sulla società sovietica stessa. Tale violenza, diretta in primo luogo – a partire dall’episodio cruciale della collettivizzazione-dekulakizzazione – contro l’immensa maggioranza della nazione, i contadini, percepiti dal regime come una massa ostile, <<oscura>> e reazionaria, fu perpetrata in nome di un progetto volontaristico di trasformazione radicale delle strutture sociali ed economiche, grazie al quale si sarebbe forzata la storia e recuperato in dieci anni un ritardo secolare così da trasformare il paese in una grande potenza industriale, condizione sine qua non [essenziale, indispensabile – n.d.r.] per la vittoria della politica staliniana del <<socialismo in un solo paese>>. Il risultato di quell’offensiva fu una straordinaria brutalizzazione dei rapporti tra Stato e società. La <<rivoluzione dall’alto>> messa in atto alla fine del 1929 dal gruppo stalinista – che prevedeva la collettivizzazione, la dekulakizzazione, l’imposizione di un sistema amministrativo di comando sull’economia e l’industrializzazione accelerata – sfociò in un’inedita commistione [= intreccio, fusione di vari elementi – n.d.r.] di modernizzazione (se la si può misurare in quantità di tonnellate di acciaio prodotte) e di regressione politica e sociale: <<sfruttamento militar-feudale>> della classe contadina espropriata e assoggettata a una nuova forma di servaggio, sviluppo di un sistema di lavori forzati, deportazione di centinaia di migliaia di famiglie, carestia, processi per stregoneria politica, quote di esecuzioni approvate dall’Ufficio politico, regione per regione... Punto di partenza di tale regressione, l’orgia di violenza sperimentata contro i contadini agli inizi degli anni trenta avviò un meccanismo che avrebbe colpito un numero crescente di <<nemici interni>>. Alcune cifre, oggi ben documentate, ne indicano la portata.
Nello spazio di una generazione, dalla fine degli anni venti all’inizio degli anni cinquanta, un uomo adulto su cinque passò per i campi del Gulag. Ai circa 15 milioni di sovietici condannati ai lavori forzati (di cui più di un milione e mezzo morirono in reclusione) si devono sommare gli oltre 6 milioni di persone deportate collettivamente (a gruppi familiari, persino intere etnie), con una semplice misura amministrativa, verso le regioni più inospitali del paese, dove, private dei diritti civili, furono loro imposte residenza e condizioni di lavoro e di vita tali da causare un forte aumento della mortalità (durante la deportazione circa un milione e mezzo di individui perirono).
In venticinque anni, dal 1929 al 1953, circa 3 600 000 persone vennero condannate da una giurisdizione speciale alle dipendenze della polizia politica e 777 000 di queste subirono la pena capitale. Oltre 680 000, l’88 per cento, dei condannati a morte furono giustiziati durante gli anni del <<Grande Terrore>> (1937-38), in gran parte sulla base di <<quote di esecuzione>> pianificate e approvate dall’Ufficio politico.
Occorre aggiungere a tutto ciò la brutale espropriazione di 25 milioni di abitazioni contadine. Rimane infine, per completare questo breve inventario delle violenze e dei crimini di massa, la questione – centrale – della carestia del 1932-33. che, - con i suoi 6 milioni di morti, da sola occupa un posto preponderante nel bilancio della repressione staliniana e costituisce una forma di violenza estrema e inedita: dopo essere stati collettivizzati, i contadini Kolchoziani di un certo numero di regioni agricole fra le più ricche del paese (Ucraina, Caucaso settentrionale, Terre nere) furono defraudati [= depredati – n.d.r.] della totalità del loro raccolto, per essere poi <<puniti>> per aver tentato di resistere – passivamente – a tale spoliazione. La <<punizione>> trasformò una situazione di indigenza in una terribile carestia. [...]
Nel 1930-31, la generale disorganizzazione, la mancanza totale di coordinamento tra le operazioni di deportazione condotte dall’OGPU [una delle diverse denominazioni assunte dalla polizia politica sovietica – n.d.r.] e l’insediamento dei deportati che era di competenza di autorità locali sovraccariche di compiti, trasformarono la dekulakizzazione in una deportazione-abbandono senza precedenti nella storia. Al più alto livello dello Stato-Partito, il Politbjuro costituì una <<Commissione di insediamento dei kulaki>> soltanto parecchi mesi dopo l’avvio della dekulakizzazione. Come scrive Viktor Petrovic Danilov, <<tale provvedimento ritardato rispecchiava alla perfezione la situazione generale esistente in quel periodo negli ambienti politico-amministrativi. I dirigenti politici di alto rango, al pari dei loro subordinati a livello regionale e locale, non avevano acquisito la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie decisioni>>. Dopo settimane, e persino mesi, di vagabondaggio, numerosi convogli scaricavano i <<dekulakizzati>> in piena taiga [foresta tipica della Siberia e delle regioni nordiche della Russia europea – n.d.r.], il più delle volte senza viveri né utensili. Nei primi due anni (1930-31) degli oltre 1 800 000 deportati, 500 000 morirono o fuggirono. Secondo dati frammentari sui vari gruppi di deportati, il tasso di mortalità annuale si aggirava intorno al 15 per cento per gli adulti e al 50 per cento per i bambini in tenera età. In termini di <<valorizzazione delle regioni colonizzate>>, la deportazione-abbandono fu un insuccesso clamoroso: nell’autunno del 1931 meno del 10 per cento dei deportati svolgeva un lavoro <<produttivo>>. [...]
[Quanto] alla carestia del 1932-33, appare indiscutibile la responsabilità dei dirigenti staliniani che già dall’estate del 1932 erano stati avvertiti a più riprese, grazie a rapporti tra loro concordi, a livelli diversi, e provenienti da molteplici fonti politiche, amministrative e poliziesche, del rischio e poi della realtà di tale terribile evento. Si potrebbe forse arrivare a dire che la carestia sia stata scientemente programmata in vista di un genocidio della popolazione ucraina? Un’interpretazione di tal genere è più discutibile. Pur non negando l’esistenza di una dimensione <<imperialista moscovita>> - percepita come tale dalle vittime -, uno studio geografico della carestia mostra come ne siano state colpite sia zone ucraine, senza dubbio in modo maggioritario, sia cosacche, russe e kazache. La carta della carestia coincide con quella delle aree a più elevata produzione cerealicola e quindi più soggette al prelievo predatorio dello Stato [...]. Tali zone sono anche quelle in cui più forte fu la resistenza non soltanto alla collettivizzazione, ma altresì alla politica di requisizione degli anni del <<comunismo di guerra>>.
(N. Werth, "Le logiche della violenza nell’URSS staliniana", in H. Rousso (a cura di), Stalinismo e nazismo. Storia e memoria comparate, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp. 89-91 e 95-100. Traduzione di S. Vacca)