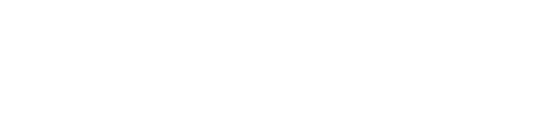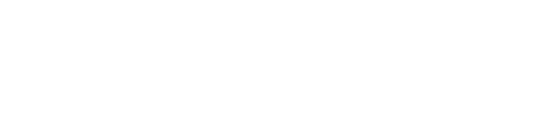Carceri, insostituibile il ruolo delle Associazioni
05.04.2013
Nel novembre 2011 l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha nominato l’Avv. Desi Bruno Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, attribuendole il compito di garantire, in attuazione a quanto previsto dalla Costituzione, i diritti delle persone detenute o in qualche modo limitate nella libertà personale.
Avvocato, perché tanta enfasi nei confronti dei diritti dei detenuti e della necessità di una nuova cultura della cura delle persone detenute o in qualche modo limitate della libertà personale?
In questo preciso momento storico è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di vita delle persone detenute.
L’8 gennaio u.s. la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato il nostro Paese per il “trattamento inumano e degradante” delle nostre carceri, disponendo il risarcimento dei danni morali subiti da sette detenuti e lasciando un anno di tempo all’Italia per adottare le misure necessarie a fronteggiare il problema con misure strutturali.
Il tempo passa, ma i problemi da affrontare sono rimasti inalterati.
Il sovraffollamento ha raggiunto livelli record: al 28.2.2013, i detenuti presenti erano 65.906, a fronte di una capienza regolamentare di 47.041. Continua a registrarsi il progressivo aumento della cd. “detenzione sociale”, ovvero di persone che vivono in uno stato di svantaggio, disagio o marginalità per le quali – più che una risposta penale o carceraria – sarebbero opportune politiche di integrazione sociale: i tossicodipendenti, gli immigrati, i detenuti portatori di disagio psichico. All’interno del carcere si vive prevalentemente in una condizione di ozio forzato. Il lavoro, quando c’è, non permette la costruzione di una professionalità spendibile all’esterno, sul mercato del lavoro.
Nella conclamata crisi del sistema di welfare, le risorse da destinare ai territori vengono continuamente ridotte: questo determina minori possibilità di presa in carico dei soggetti che escono dal carcere, alle quali conseguono – in un costante rapporto di causa-effetto – una minore concessione di misure alternative e un correlativo innalzamento del rischio di recidiva.
Insomma: oggi il carcere non solo non rieduca, ma produce forti danni. Il detenuto non viene sostenuto in un progressivo processo di responsabilizzazione, ma finisce per assuefarsi alla cultura informale del penitenziario, fatta di piccoli sotterfugi, soprusi, stratagemmi di sopravvivenza in una realtà di forte sofferenza.
Il dibattito sulle carceri, tanto attuale oggi, riguarda anche la necessità di fare di questi luoghi lo spazio condiviso per nuove opportunità di riscatto personale e di reinserimento nella società. A Sua conoscenza, esistono degli esempi virtuosi nel panorama nazionale o regionale da portare all’attenzione dell’opinione pubblica?
In Italia esistono delle strutture detentive che vengono comunemente definite “carceri modello”. In particolare viene portata ad esempio l’esperienza del carcere di Bollate, dove la maggioranza dei detenuti lavora o comunque è fattivamente impegnata. Nel panorama regionale mi sento di poter dire che, in assenza di istituti modello soprattutto a causa del sovraffollamento, mi hanno comunque positivamente colpito le realtà carcerarie più piccole, come Ravenna e Forlì, dove è più evidente il tentativo della direzione penitenziaria di umanizzare la pena e di coinvolgere le persone ristrette in un rapporto costruttivo e coinvolgente e dove è più stretto il rapporto con il territorio .
Quando si parla di esempi virtuosi, però, bisogna ricordare che si tratta di istituti all’interno dei quali le “cose funzionano”, nel senso che lì avviene quello che normalmente dovrebbe avvenire in tutti gli istituti penitenziari: perché il fenomeno del sovraffollamento non supera la soglia della tollerabilità, perché i detenuti hanno la possibilità di dare senso alle proprie giornate impegnandosi non solo in attività scolastiche e di formazione professionale, ma anche in attività ricreative stimolanti. Se la qualità della vita all’interno degli istituti è buona, se il detenuto viene stimolato a riconsiderare criticamente il senso delle proprie scelte di vita attraverso un’offerta positiva di occasioni trattamentali, questo probabilmente non esclude il rischio di recidiva, ma sicuramente – in assenza di un percorso del genere – la recidiva certa e la pena si traduce di una irrogazione di sofferenza fine a se stessa. Ecco perché è importante portare all’attenzione dell’opinione pubblica non solo le croniche disfunzioni del pianeta carcere, ma anche gli esempi virtuosi: perché in questo momento storico assistiamo ad un pericoloso arretramento delle politiche di integrazione sociale, pericoloso anche se – attraverso quelle politiche – non siamo certi di poter garantire effettiva integrazione.
La situazione delle carceri è molto problematica tanto in Emilia-Romagna quanto nel resto del territorio nazionale. Secondo Lei, in che misura un’azione di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica potrebbe produrre degli effetti positivi sulle condizioni di vita all’interno delle carceri e per la collettività?
Sicuramente un’efficace azione di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica dovrebbe riguardare la cd. legge Smuraglia (peraltro, recentemente rifinanziata), che prevede agevolazioni contributive e sgravi fiscali per le imprese e le cooperative sociali che favoriscono l’inserimento lavorativo dei detenuti.
Il lavoro retribuito dei detenuti è un tema estremamente importante e delicato, perché – senza un lavoro in grado di garantire un pur minima certezza economica – anche il più autentico e condiviso percorso riabilitativo rischia di naufragare.
Uno degli scopi di questa iniziativa è quello di far conoscere la realtà spesso sconosciuta del carcere attraverso il racconto delle associazioni che se ne occupano. Secondo Lei, quale è il ruolo del Terzo settore regionale e quale l’apporto dei servizi?
Da tempo l’apporto del cd. Terzo settore è positivamente riconosciuto, anche dalla stessa Amministrazione Penitenziaria regionale e nel tempo sono stati siglati importanti Protocolli. A ciò si aggiunge che di fronte al sovraffollamento carcerario e alla diminuzione di risorse il contributo delle associazioni è spesso decisivo per assicurare il soddisfacimento di bisogni alimentari, come nel caso delle forniture di indumenti ai molti detenuti privi di mezzi.
Il volontariato – e l’associazionismo in genere – svolge un insostituibile ruolo di “ponte” tra il dentro e il fuori e di sostegno nella realizzazione delle opportunità trattamentali: nella nostra Regione come altrove. La cooperazione sociale, sia di tipo A che di tipo B, esprime poi fortissime potenzialità nella presa in carico dei soggetti in esecuzione penale esterna: in questo contesto non vanno trascurate le peculiarità del sostegno da offrire alle persone tossicodipendenti.
Se il Terzo settore rappresenta una presenza sempre più imprescindibile a supporto delle politiche carcerarie e post-carcerarie, è però fondamentale assicurare tutti gli sforzi necessari affinchè il loro intervento possa avvenire in modo economicamente sostenibile, maggiormente programmato e sinergico.
Il problema relativo alle carceri si traduce anche in tagli alle professionalità che operano al loro interno (educatori, medici, assistenti sociali, psicologi, agenti di polizia penitenziaria ). In che misura, a Suo avviso, questo incide sulla qualità di vita dei detenuti e come valorizzare il supporto di questi operatori?
Il carcere è un’istituzione totale e, come tale, “vive” attraverso il lavoro delle figure professionali ad esso preposto: non potendo gestirsi autonomamente, il detenuto deve essere preso in carico a 360 gradi. Comunemente si dice che la detenzione dovrebbe privare il detenuto della sola facoltà di locomozione, mentre tutti gli altri diritti dovrebbero essergli mantenuti integri.
Al di là della esperibilità pratica di un tale assunto, resta fermo un fatto: i detenuti devono mangiare, devono potersi lavare, cambiare di abito, devono poter uscire all’aria aperta, devono potersi curare e via discorrendo. In aggiunta a tutto questo, il carcere deve garantire anche dal pericolo di fuga dei soggetti reclusi e uno stato di adeguata vivibilità interna.
E’ evidente che i tagli progressivi e la continua contrazione del personale mettono a serio rischio la soddisfazione di tutte queste esigenze. Il personale che opera all’interno del carcere, già segnato da una condizione di lavoro situazionalmente complessa, deve essere messo nelle condizioni di operare con serenità: garantendo numeri adeguati e professionalità dell’intervento.